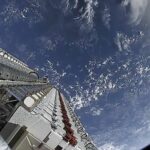Da Stoccolma a Roma, una cortina reazionaria sta calando sull’Europa. Si potrebbe parafrasare il celeberrimo ammonimento di Churchill sulla cortina di ferro per dare un contesto più organico e completo alla vittoria della destra in Italia. Quanto è accaduto domenica, infatti, non è l’effetto di insipienze e pasticci di dirigenti incapaci o inadeguati; tanto meno l’effetto di prodigiose campagne elettorali. Certo, è anche questo – ma, come sempre in politica, la soggettività segue l’oggettività, e la fragilità dei vertici è la proiezione di ambiguità ed eclettismi della base sociale. Se continuiamo ad avere questo atteggiamento tipicamente conservatore, per cui la politica la fanno i leader, questo è già un modo per ratificare la vittoria dei postfascisti. Dobbiamo essere di sinistra proprio nella fase dell’analisi e della lettura delle dinamiche sociali; altrimenti, come diceva Albert Einstein, “se continuiamo a fare le stesse cose, accadrà quello che è sempre accaduto”.
In un magnifico film di Luigi Magni, In nome del Papa re, un grande Manfredi che interpreta un abate di curia, parlando con un cardinale alla vigilia di Porta Pia, gli dice: “Eminenza, qui non è che finisce tutto perché arrivano i piemontesi, qui arrivano i piemontesi perché è finito tutto”. Cerchiamo allora di capire cosa e dove sia finito tutto prima dell’arrivo dei barbari.
Lo spostamento consistente e diffuso dell’elettorato italiano a destra è un processo che viene da lontano, e soprattutto ha una dimensione globale. Se proprio vogliamo dare un giudizio sintetico circa quanto è accaduto, potremmo dire che in Italia è cambiato poco dal 2018: i voti, che già videro una prevalenza delle componenti più populiste, si sono concentrati verso un’area più strutturalmente reazionaria, ma il campo della sinistra è rimasto sostanzialmente quello, dopo le mille contorsioni di questo quadriennio, in cui pandemia, guerra e recessione economica sembrano essere passate come acqua su vetro. In realtà, è cambiato il mix di interessi e di composizione sociale del voto di destra, così come lo è stato in Europa. La novità è la scelta vandeana della tranquilla imprenditorialità lombarda e veneta, ma anche questo è un dato tutto europeo.
Le elezioni – sia nella Francia del dualismo fra Macron e Le Pen, sia in Germania, dove alla debolezza del partito di governo di Angela Merkel non ha corrisposto un’avanzata della sinistra socialdemocratica, e ancora in Inghilterra, con il coriaceo radicamento di un governo apertamente classista, o nella radiosa Svezia del welfare, dove la socialdemocrazia si vede accantonata da una forza chiaramente radicalizzata a destra – ci dicono che il tramonto, ormai irreversibile, del vecchio patto fra capitale e lavoro ha lasciato un cratere che la sinistra non riesce a colmare.
Questa è la matrice della sconfitta, non i balbettii di Letta o l’amalgama non riuscito del Pd. Siamo nel gorgo di una riclassificazione degli interessi di classe, in base alla collocazione di ceti e individui nei processi produttivi, che non hanno più niente a che fare con il lavoro come lo ricordiamo.
È davvero singolare che nessuno rammenti che Mirafiori, ancora dodici anni fa, era abitata da cinquantamila lavoratori, e oggi sono meno di ottomila; oppure che nel collegio di Sesto San Giovanni, nell’ex cintura operaia milanese, dove la figlia del fondatore di Ordine nuovo, Pino Rauti, ha battuto il figlio del deportato Fiano, al posto di trentamila lavoratori, occupati in cinque fabbriche, ci sono trentamila persone che lavorano in aziende che, al massimo, hanno un numero di dipendenti non superiore a tre.
Mentre ci si diletta con il folclore delle battute di Berlusconi su Tik Tok, ignoriamo che trentotto milioni di italiani quotidianamente affidano le proprie relazioni e linguaggi agli arbitrati di un algoritmo, che non è né di destra né di sinistra, ma sicuramente neanche neutro. È in questo intreccio fra social e mutazione genetica del lavoro che la sinistra si è dissolta – come dice Aldo Bonomi.
Insomma, abbiamo subito una sconfitta marxista, legata ai rapporti di produzione, a un cambio di mulino, avrebbe detto il grande vecchio di Treviri, e non alla psicologia di qualche candidato fragile. Una sconfitta che inizia nel 1989, quando con il Muro di Berlino crolla ogni possibile narrazione di una sinistra che ha voluto, o potuto, al massimo cambiare indirizzo e nominativo, ma certo non cultura, radicamento e identità. Siamo rimasti quelli delle feste dell’“Unità”, con il macabro paradosso di celebrarle senza “l’Unità”. E nel frattempo si automatizzava la vita, la produzione diventava un algoritmo, il consumo una profilazione, la politica un social.
Socialisti e comunisti si disperdevano, e poi sparivano ovunque nel mondo; e in Italia, come al solito, abbiamo pensato di essere più furbi di tutti, avendo anticipato il colpo, con il sotterfugio di cambiare il nome del Pci prima degli altri per non pagare dazio. Eppure avevamo pagato già duramente: prima nel ’94, con la discesa in campo di Berlusconi, e poi, successivamente con mille rimaneggiamenti e annacquamenti, fino a portarci in casa la mutazione genetica con la segreteria Renzi, che tagliò il cordone ombelicale con gli esecutori testamentari del Pci, ma senza che il nuovo potesse sostituire il vecchio che moriva – per tornare a Gramsci.
Ogni volta, avevamo l’alibi dell’emergenza per coprire il buco della rappresentanza sociale, con una pensata geniale per le elezioni: prima Prodi, poi il pragmatismo di Fassino, seguito dal famoso I care di Veltroni; successivamente, il tatticismo di Franceschini, quindi il velleitarismo di Bersani e l’ombra di D’Alema, che ne sapeva sempre una più del diavolo. Il partito si squagliava, e la sua evanescenza veniva coperta imbarcando avventurieri, questuanti, cacicchi e governatori. Le città diventavano musei della memoria, dove la sinistra si basava su anziani percettori di spesa pubblica, assediati da plebi delle periferie che cercavano – come diceva dei totalitarismi Hannah Arendt – di giocarsi un ruolo nella storia, anche a costo della propria distruzione.
La Lega rubò i secondi e i penultimi alla sinistra, che si illudeva di reggere con l’alleanza illuminista fra i primi e gli ultimi. Poi vennero i reazionari di massa, prima negli Stati Uniti e poi in Europa, dove élite speculative si basavano sul consenso di moltitudini di emarginati, in cui ognuno era povero a modo suo.
In questo scenario – che caratterizza l’Occidente, da Trump alla Brexit –, in cui i ceti disagiati pensano e votano da ricchi rancorosi contro i privilegi delle élite liberal, attraversiamo le tempeste della pandemia e della guerra rinserrati nei nostri centri storici. La destra tesse una nuova trama di sovversione sociale, connettendo “no tax” a “no vax”, e indicando nella ipocrita democrazia occidentale il nemico di classe.
È la borghesia imprenditoriale, che apre la strada all’eversione di massa: la mascherina diventa, come il reddito di cittadinanza, l’emblema di un assistenzialismo parassitario. Qui sia la chiave di volta del ciclone Meloni: una solida alleanza sociale che combina l’antistatalismo predatorio della piccola e media azienda con l’assistenzialismo senza leggi dei ceti più periferici. Il lavoro non parla in questo gorgo, e, quando parla, riflette le ambiguità di essere parte di questa alleanza in componenti non limitate, come dimostra l’ambiguità della Cgil sui vaccini. Illuminante è una riflessione di Franco De Felice, alla fine degli anni Ottanta, quando coglie il formarsi di schieramenti sociali ibridi, attraversati da venature parassitarie e corporative di cui le aree operaie sono parte: “Il modo di procedere della crisi del welfare in Italia sembra risolversi nella definizione di due grandi schieramenti. Il primo comprende settori più colpiti dalla riorganizzazione e conversione industriale, ed anche quelle fasce sociali, o parti di esse, che hanno svolto un ruolo importante nella creazione di quel sistema di garanzie del reddito che tendono a difendere: uno strano intreccio tra sezioni del movimento operaio, settori produttivi maturi o tradizionali ed ampi strati burocratici o professionali, che hanno nei grandi apparati gestori della politica sociale le proprie radici. Un secondo schieramento annovera i settori più dinamici del capitalismo (soprattutto la piccola e media impresa) ed ampi strati sociali non tutelati, o vivacemente critici delle forme in cui le politiche sociali hanno trovato attuazione: un altro intreccio, non meno strano e singolare, ma non inedito nella storia italiana, fra liberismo privatistico e antistatalismo popolare-democratico. Si fa più chiaro che la crisi del welfare è un fattore di accelerazione di quella dello Stato-nazione” (Franco De Felice, La nazione italiana come questione. Dimensione e problemi della ricerca storica, 1993).
Una citazione lunga, ma che fotografa proprio il momento del big bang. Siamo appunto qualche anno dopo il fatidico ’89, in cui la classe operaia perde il suo ruolo di movimento complessivo politico scomponendosi in ceti rivendicativi e neocorporativi: la politica diventa una gilda, in cui ognuno cerca un proprio sindacalista che tuteli l’interesse momentaneo. Ogni elezione diventa, dunque, il confronto fra queste neocorporazioni che danno e ritirano la delega ai brand politici. La cosiddetta volubilità elettorale è l’effetto di questa dinamica di sindacalizzazione della politica.
In quest’ottica, la sequenza delle giravolte degli elettori, in questi anni, diventa più decifrabile e meno eccentrica. La massa dei lavoratori senza più missione diventa la base sociale di una vandea antistatalista, preda dei ceti più intraprendenti che, a cavallo della spesa pubblica, estraggono rendite dai nuovi servizi, decentrando la produzione prima al Terzo mondo, poi all’automatizzazione. A chi si parla nel deserto di Mirafiori, come si organizza il formicaio di Sesto San Giovanni? A queste domande non si risponde perché nessuno le formula. Si esorcizza la propria irrilevanza sociale con la visibilità, oppure il dinamismo digitale, sostituendo la rappresentanza con i click. Il partito è solo retrovia degli eletti, e il territorio lascia ai linguaggi emotivi della rete il compito di alfabetizzare chi vuole essere in prima linea.
Salvini coglie questa mutazione – e sposta il leghismo dall’eccezione regionale alla dimensione nazionale: una federazione di rendite per privatizzare lo Stato. È il modello della sanità lombarda, che miete migliaia di vittime nella pandemia, ma che nessuno denuncia come crimine contro l’umanità. Anzi, viene oggi declamato con la candidatura di Moratti al vertice della regione caldeggiata da Meloni. L’infatuazione per la Lega nazionale dura poco. In qualche mese si passa dal 30 % delle europee al precipizio dell’8%.
Nel Sud, il trasformismo ex Dc, che aveva puntato su Salvini, si trasferisce in parte sulla carovana postfascista, ma il nodo riguarda il Nord: perché il tappeto di imprese lombardo-venete, connesse all’indotto tedesco, che pure registrano fatturati stratosferici nei mesi successivi alla prima ondata pandemica, butta a mare Draghi per la Meloni? Questo è il quesito che dà nerbo alle elezioni: perché quel capitalismo molecolare, che aveva trovato un equilibrio, entra in agitazione e segue l’ondata sovranista? Siamo dinanzi a una nuova marca di capitalismo locale, opposto alla globalizzazione finanziaria internazionale, che vuole protezione e sostegno per sganciarsi anche dalla servitù tedesca. Il sogno è tramite le nuove tecno-strutture e una logistica concorrenziale, pronte addirittura ad affiancarsi se non a sostituire la locomotiva tedesca. Le banche del marco sono il nemico, non più il gigante da arruffianarsi con l’imitazione del modello bavarese. In questa svolta, c’è molto della svolta reazionaria: si immagina un modello olandese di spesa pubblica senza Stato, di sostegno senza programmazione, di innovazione senza socializzazione. E soprattutto senza fisco e sindacato. Siamo a un capitalismo estrattivo – come scriveva Mariana Mazzucato nel suo ultimo saggio Il valore di tutto (edito da Laterza).
Tre sono le strade per contrapporsi alla deriva olandese: il sindacalismo neocorporativo, quello che i grillini hanno inaugurato, quasi a loro insaputa, con i micro-contratti per il reddito di cittadinanza al Sud, in cui si cerca un capitalismo compassionevole che dia mance alle aree marginali di lavoro nero; la rincorsa di Calenda a un inesistente ceto medio riflessivo, che eredita parte del voto liberal del Pd, ma non morde la base sociale moderata, che ormai si è radicalizzata strutturalmente; infine la ricostruzione di una sinistra del conflitto cognitivo, che ridisegni la sua base sociale nei processi di assemblamento del capitalismo tecnologico, ritrovando negoziato e mediazione politica nell’organizzazione dei processi di contesa della titolarità dei saperi e delle tecnologie di relazione sociale. Stiamo parlando di un partito che si combini nelle università con i patti territoriali, nei distretti con le reti della logistica produttiva, nelle città con la competizione diretta con le metropoli europee. Un partito che assuma la questione sanitaria come base di un’idea di diritti universali e di scienza condivisa. Un partito che, sulla base di una capacità di conflitto e contrasto, possa poi anche estendere la sua tutela ai ceti marginali e periferici, integrando i reparti del lavoro in alleanze territoriali per uno sviluppo trasparente e programmato. Certo, un partito difficile, articolato, organizzato sui processi di partecipazione alle decisioni e non alle consultazioni. Un partito che produca e sostituisca costantemente i propri dirigenti, ogni volta che viene raggiunto un obiettivo.
Il congresso che Letta ha appena lanciato, cercando di renderlo precotto nei tempi lunghi, per un atterraggio morbido del suo contrattato successore, andrebbe convocato subito e tenuto permanentemente aperto: un congresso che sia un forum di accesso e partecipazione alle decisioni di un apparato sempre più spalmato sul territorio. Una vera costituente dei saperi e dei mestieri autonomi e trasparenti. Un congresso dei Grundrisse e non più della memoria del Capitale. Una follia – dirà qualcuno –, ma di quante cose apparentemente concrete e funzionali siamo stati vittima? Il comunismo, secondo Brecht, è quella cosa facile a dirsi ma difficile a farsi. Anche il riformismo lo è.