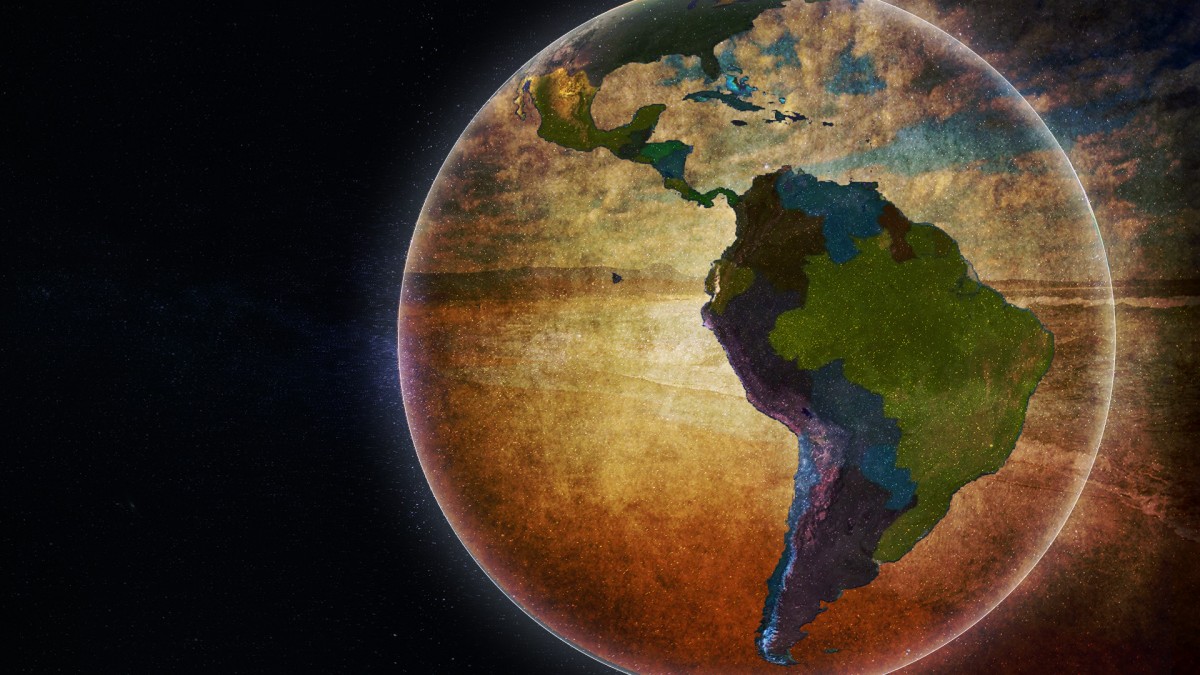
Dopo il crollo del Muro di Berlino, l’America latina ha vissuto un periodo di egemonia neoliberale. Cadute le feroci dittature caratterizzanti la sua storia recente, le grandi masse che, con il ristabilirsi di relazioni democratiche avevano conquistato un diritto di partecipazione alla vita politica, non trovavano più rappresentati i loro interessi in quei partiti storici sopravvissuti alla lunga notte della democrazia. Si apriva così uno spazio immenso per nuove formazioni politiche. Nasceva l’“onda rossa” iniziata con Hugo Chávez in Venezuela, seguito poi da Lula da Silva in Brasile, da Nestor Kirchner in Argentina, da Evo Morales in Bolivia, da Rafael Correa in Ecuador: una stagione che va sotto il nome di “socialismo del Ventunesimo secolo”. Si affacciava allora alla ribalta una sinistra che – potendo contare su un momento particolarmente favorevole dal punto di vista economico, in primo luogo sugli alti prezzi delle materie prime – ha governato grosso modo per due decenni, trasformando le economie dei rispettivi Paesi, riuscendo in qualche caso a strappare larghe masse di popolazione alla fame, e persino a creare una nuova classe media di consumatori.
Come sia poi finita quella stagione è cosa nota. Travolta da un’involuzione democratica – è il caso del Venezuela –, da tentazioni di aggrapparsi al potere – com’è successo a Morales – oppure da accuse di corruzione – com’è accaduto a Rafael Correa, condannato definitivamente, e a Lula, prima condannato e infine scagionato. L’onda rossa ha lasciato spazio a una breve stagione, in cui è tornata a governare la destra, senza peraltro riuscire a stabilire una duratura egemonia com’era accaduto in precedenza. Colpevole di drammatici fallimenti – come nel caso di Mauricio Macri in Argentina e di Sebastián Piñera in Cile –, potrebbe porre fine al suo quadro negativo se, nel prossimo ottobre, Bolsonaro riconsegnasse a Lula un Brasile portato allo stremo dalla sua nefanda presidenza. Si chiuderebbe così il cerchio della nuova onda di sinistra, che solo nell’anno in corso ha visto passare ai progressisti Honduras, Cile e Colombia. Se si prendono in considerazione gli eterogenei esperimenti in cui la sinistra è attualmente al potere – dall’Argentina, al Messico, al Perù campesino di un sempre più in difficoltà Pedro Castillo –, le forze che si richiamano a ideali progressisti governano la maggior parte dei seicentocinquanta milioni di cittadini latinoamericani.
Ciò detto, dalla fine del secolo scorso le condizioni generali sono mutate, diverso è l’approccio della sinistra che si affaccia al potere, dato che, rispetto a quella che l’ha preceduta, essa coniuga riforme sociali e rispetto delle libertà e delle regole democratiche, ridistribuzione della ricchezza, diritti della persona e ragioni ambientali. Come diverse, e notevolmente più scarse, sono le risorse su cui la “nuova sinistra”, che sta dando di sé le prime prove, potrà contare. Scarsità più che abbondanza sarà il leitmotiv dei governi della sinistra odierna, alla quale sarà precluso per lo più il meccanismo della distribuzione a pioggia delle risorse, a cui invece ha potuto far ricorso quella del passato. È una sinistra che pare consapevole delle sfide che dovrà affrontare, e che si pone il problema del superamento dell’economia estrattivista e della lotta al cambiamento climatico. Temi sconosciuti a quella che l’ha preceduta. Oltre all’obiettivo storico del superamento delle disuguaglianze, che rendono l’America latina politicamente e socialmente instabile. Va da sé che gli esperimenti più interessanti riguardano Paesi come il Cile, la Colombia e, qualora prossimamente vincesse Lula, il Brasile.
Gabriel Boric ha ereditato un Paese politicamente spaccato, fiaccato dall’epidemia, impoverito dalla crisi economica, con un’inflazione all’11% a fine anno e un dollaro alle stelle. La questione delle violenze delle minoranze degli estremisti mapuche, le manifestazioni contro la migrazione illegale alla frontiera nord, fomentate dalla destra, la criminalità veicolata dalle bande del traffico di esseri umani, hanno oscurato il piano Chile Apoya, con il quale il suo governo ha esordito, al fine di varare misure per far fronte alla frenata dell’economia, calmierare i prezzi dei combustibili, creare mezzo milione di posti di lavoro. Il suo progetto di riforma tributaria introduce una tassa sul patrimonio per le persone con fortune superiori a cinque milioni di dollari e aumenta le royalties per le aziende che producono più di cinquantamila tonnellate di minerali all’anno, con l’obiettivo di migliorare i diritti sociali dei cileni riguardo alla salute, al sistema pensionistico e al social housing. Nei sondaggi però non sfonda: domenica scorsa è aumentato di due punti raggiungendo il 38% del gradimento, ma il 58% dei cileni lo disapprova. Governa tenendo d’occhio la scadenza del 4 settembre, data del referendum sulla nuova Costituzione, quando i cileni saranno chiamati a decidere se vogliono una nuova Carta fondamentale, oppure preferiscono mantenere quella del 1980 di Augusto Pinochet, che delega al privato tutta una serie di materie, conservando l’impianto neoliberista. Anche qui i sondaggi non sono benigni: favorevoli il 37% – un calo di un punto di chi è contrario a destra e in parte nel centrosinistra (52%) –, mentre l’11% rimane indeciso. Il 74% dei cileni è comunque d’accordo sull’avvio di un nuovo processo costituente nel caso dovesse vincere il rifiuto.
L’ex presidente socialista Ricardo Lagos ha evidenziato i problemi che il Cile si troverà ad affrontare qualunque risultato ne scaturisca, dato che questo sarà comunque di stretta misura, lasciando il Paese polarizzato. Ha proposto perciò di continuare il dibattito fino a raggiungere una Costituzione in cui possa riconoscersi la maggioranza dei cileni. Boric si è detto disposto a introdurre migliorie al testo, nel caso esso fosse approvato dal prossimo referendum. E ha detto che, se dovesse prevalere il rifiuto, il suo governo promuoverà un nuovo processo costituente in parlamento, dato che l’attuazione del programma non avrebbe storia se non riuscisse a rompere la gabbia neoliberista in cui la Costituzione pinochetista ha rinchiuso il Cile. Col nuovo testo, il Cile diventerebbe uno Stato paritario, in cui alle donne sarebbe destinata la metà dei posti in tutti gli organi statali e il diritto all’aborto sarebbe assicurato. Il Paese diventerebbe uno Stato plurinazionale e interculturale, con “autonomie regionali indigene”. Cesserebbe la delega al privato per la salute, l’educazione, le pensioni, il lavoro e la questione abitativa. Verrebbe introdotto un sistema pubblico di sicurezza sociale, finanziato con reddito nazionale e contributi obbligatori. Per quanto riguarda la salute, infine, è proposta la creazione di un sistema sanitario nazionale.
In Colombia, il 20 luglio, si è installato il nuovo parlamento, che esprime una maggioranza di centrosinistra. Una novità eclatante, dovuta al lungo lavoro di tessitura del neoeletto presidente Gustavo Petro che, in attesa di entrare in carica il prossimo 7 agosto, sta facendo di tutto per dimostrarsi meno radicale di quanto sia stato un tempo. È del resto favorito dalla grande popolarità di cui gode nel Paese. Lo schieramento che lo appoggia conta 63 senatori su 108, e 106 dei 188 rappresentanti alla Camera, mentre Petro ha ottenuto, con il suo Pacto Historico, 20 senatori e 28 deputati, non certo sufficienti a garantirgli la maggioranza nelle assemblee legislative. Scontato l’appoggio di Alleanza verde e di Comunes, il partito espressione dell’ex guerriglia delle Farc, ha chiuso un accordo con il Partito liberale e, pochi giorni fa, con Dillian Francisca Toro, una ex senatrice che attualmente guida il partito “La U”, fondato nel 2006 con l’apporto dell’ex presidente Álvaro Uribe, il grande avversario politico di Petro. Nel frattempo, ha nominato al ministero degli Esteri Álvaro Leyva, politico conservatore promotore degli accordi di pace all’Avana tra il governo di Juan Manuel Santos e la guerriglia delle Farc; a quello dell’Economia, José Antonio Ocampo, professore a Harvard e a Yale; mentre la Riforma agraria va a Cecilia López, con l’indicazione di agire nel rispetto della proprietà privata. Ministro dell’Educazione è Alejandro Gaviria, accademico moderato, ex ministro della Salute di Manuel Santos e rettore dell’Università delle Ande. Il suo compito sarà quello di “ottenere l’educazione superiore pubblica e gratuita”, “centri di eccellenza universitari pubblici centrati sulla ricerca” e “aumentare sostanzialmente il numero di bambini e bambine nella fascia prescolare”. Ambasciatore a Washington, Luis Gilberto Murillo; all’Onu, Leonor Zalabata Torres, indigena arhuaca nota internazionalmente per la sua attività in difesa dei diritti umani. Tutte nomine azzeccate, apprezzate anche dall’opposizione. Rappresentante di un ambiente politico che non ha mai retto le redini del potere, Petro interpreta la necessità di cambiamento della classe dirigente e dello stesso sistema. Finora, sembra aver fatto le mosse giuste, e la luna di miele col Paese appare del tutto meritata.
Mancano ormai, invece, non molte settimane al 2 ottobre, giorno in cui i brasiliani andranno alle urne per scegliere tra il presidente in carica Jair Bolsonaro e Luiz Inácio Lula da Silva, mentre il Paese vive nel clima di uno scontro che il leader di estrema destra dipinge come un duello tra “bene contro male” e come “amore contro odio”. Pesa quest’atmosfera di profonda radicalizzazione in cui da tempo il Brasile sta scivolando: un motivo di preoccupazione per il quartier generale del presidente in carica, dato che quanto accade indebolisce il discorso a favore della libertà di armarsi e rafforza l’immagine bellicosa di Bolsonaro, rendendogli difficile ottenere i voti degli indecisi. Secondo i sondaggi, Lula mantiene un ampio vantaggio e potrebbe persino vincere al primo turno. L’ultima rilevazione di Datafolha dà al candidato progressista il 47% delle intenzioni di voto, rispetto al 28 di Bolsonaro. Lula ha stretto un’alleanza con il suo ex avversario Geraldo Alckmin, e cerca di estendere il suo messaggio oltre i confini della sinistra. Qualora vincesse, difficile che possa recuperare le direttrici dei governi targati Partito dei lavoratori, che hanno guidato il Brasile tra il 2003 e il 2016, per quattro mandati consecutivi.
Bolsonaro ha deluso buona parte di chi lo aveva sostenuto, soprattutto per quanto riguarda il contrasto alla pandemia. Andando, ultimamente, contro il discorso ultraliberale e le promesse di severo controllo della spesa pubblica che hanno segnato la sua campagna, ha fatto approvare dal parlamento una proposta che dichiara il Paese in “stato di emergenza” fino a fine anno, varando un pacchetto di aiuti sociali a meno di tre mesi dalle elezioni. Ricorrenti sono i suoi attacchi contro il sistema di voto elettronico, che accusa, senz’alcuna prova, di consentire brogli a favore della sinistra, alimentando una narrazione di “vittoria rubata” nel caso uscisse sconfitto, arrivando a minacciare colpi di Stato e insurrezioni armate da parte dei suoi fedeli. Il 20 luglio, ha annunciato intanto la sua candidatura Ciro Gomes del Partito democratico laburista, affiliato all’Internazionale socialista. Si è presentato come terza via tra i due maggiori contendenti, ed è dato al momento al 10%.
Lula è consapevole di muoversi su un terreno difficile, su cui ogni errore può favorire l’avversario, che potrebbe persino essere premiato per i suoi più recenti provvedimenti, chiaramente improvvisati e di breve durata, messi in campo per alleviare i disagi delle fasce sociali più colpite dalla crisi economica. Ma lo scotto che Lula ha dovuto pagare è stato quello di una sorta di metamorfosi della propria fisionomia politica, così da coprire l’intero campo democratico. Questo è allo stesso tempo il suo punto di forza, in quanto esprime la capacità di unire le più diverse anime del variegato panorama democratico, e rappresenta anche la sua irriducibile debolezza, per l’inevitabile venir meno di un nucleo programmatico fortemente caratterizzato. Per il momento, si limita a descrivere la coalizione che lo sostiene come l’alternativa all’autoritarismo e alle minacce alla democrazia rappresentate da Bolsonaro, lasciando nel vago gli obiettivi del governo. Manca un’idea di fuoriuscita dalla crisi sociale e democratica – quella di cui Bolsonaro ha approfittato per vincere, e in cui ha vieppiù precipitato il Brasile –, e non si intravede, da parte di Lula, un programma politico che ruoti intorno ai temi in grado di riformare il Paese. La mancanza di chiarezza espone drammaticamente il probabile futuro esecutivo al rischio di un insuccesso, dietro al quale potrebbe farsi strada la versione peggiore dell’estrema destra.











