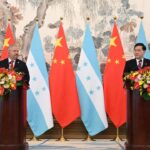È di alcuni giorni fa la notizia di una donna condannata a trent’anni di carcere per un aborto spontaneo: no, non è un racconto distopico in stile The Handmaid’s Tale, è la realtà che vivono ogni giorno, da anni, le donne in El Salvador. Il piccolo Paese del Centro America ha approvato, infatti, una delle norme più restrittive in materia di aborto, secondo cui dal 1998 l’interruzione di gravidanza è illegale e penalmente perseguibile, perfino in caso di aborto spontaneo. Questo rappresenta, anche a livello internazionale, una violazione dei diritti umani delle donne alla vita e alla salute. Nel tentativo generale di limitare l’accesso delle donne all’aborto legale, con una riforma della Costituzione salvadoregna, nel gennaio 1999, è stato modificato l’articolo uno, inserendo la protezione del diritto alla vita di ogni individuo fin dal momento del concepimento, rendendo in questo modo il ricorso all’aborto contrario alle norme costituzionali.
L’ultima donna a essere vittima di questo sistema giudiziario fortemente restrittivo, identificata solo come “Esme”, è stata condannata lunedì scorso, dopo quasi due anni trascorsi in custodia cautelare. La ragazza era stata arrestata nel 2019, su segnalazione del personale medico, dopo essersi recata in ospedale per chiedere soccorso in seguito a un aborto spontaneo. Lo stesso trattamento era stato riservato prima a Sara Rogel, prima ancora a Evelyn Beatriz Hernández Cruz, e negli ultimi vent’anni a più di 180 donne. Infatti, anche se il codice penale di El Salvador prevede una pena dai sei agli otto anni per i casi di aborto, i giudici spesso condannano le donne per “omicidio aggravato”, attribuendo loro una pena che va fino ai trent’anni di carcere.
“La condanna di Esme è un devastante passo indietro per i progressi compiuti nella criminalizzazione illegale delle donne che soffrono di emergenze ostetriche in El Salvador”, ha affermato Paula Avila-Guillen, avvocata internazionale per i diritti umani e direttrice esecutiva del Women’s Equality Center. Avila-Guillen ha avvertito inoltre che, nell’ipotesi in cui gli Stati Uniti dovessero decidere di ribaltare definitivamente la Roe versus Wade – la sentenza della Corte suprema del 1973, che ha legalizzato l’aborto a livello nazionale negli States –, casi simili potranno diventare comuni in tutto il mondo. La mano dura decisa da El Salvador è stata oggetto di forte critica anche da parte della Corte interamericana dei diritti umani, che nel novembre dello scorso anno ha stigmatizzato la violazione dei diritti umani compiuta nei confronti di una donna, identificata come Manuela, condannata per avere violato la normativa statale sull’aborto, e morta in carcere mentre scontava una pena a trent’anni di reclusione.
In risposta ai duri provvedimenti presi da El Salvador, è nata la campagna Nos faltan las 17 (ossia “Ci mancano le 17 – donne”),nel cui appello si legge che, ogni anno, il 20% delle gravidanze nel mondo presenta complicazioni e/o emergenze, e la perdita di una gravidanza può verificarsi in qualsiasi momento per vari motivi. Tuttavia, quando le donne in El Salvador vivono questa esperienza, vengono arrestate, portate in prigione e condannate.
La legislazione estremamente proibitiva del Paese comporta l’incarcerazione sistematica di donne e ragazze, che soffrano di qualsiasi emergenza ostetrica. Ed è possibile affermare che, proprio a causa della totale penalizzazione dell’aborto, le ragazze siano praticamente costrette a diventare madri, a costo di mettere a rischio la loro vita, perché i loro corpi non sono preparati per la gravidanza e il parto.
Oltre al rischio di una pena durissima, oltre alle complicazioni di salute fino alla possibilità di morte, le donne in El Salvador vivono sui loro corpi continue mortificazioni che generano gravi problemi psicologici: basti pensare che le vittime di stupro sono costrette a portare a termine la gravidanza, così come le donne con gravidanze non vitali. Si registra anche un aumento della mortalità legata agli aborti non sicuri, quelli praticati da persone prive delle competenze necessarie o in ambienti in cui manchino standard igienici minimi. E a causa della criminalizzazione dell’aborto, le donne generalmente evitano di andare in ospedale quando affrontano momenti di difficoltà, siano essi legati alla gravidanza o siano conseguenza di un aborto non sicuro: temono di essere denunciate alle autorità.
Ci sono stati però dei casi in cui è stato possibile agire, nel contesto legislativo attuale, senza cadere nell’illegalità: come quello di “Beatriz”, una giovane donna salvadoregna, affetta da lupus, rimasta incinta nel 2012. I medici raccomandarono da subito un aborto terapeutico, per non metterne a rischio la sopravvivenza, e anche perché il feto presentava anomalie congenite. Tuttavia, i medici del sistema sanitario pubblico non interruppero la gravidanza per paura di essere oggetto di ripercussioni penali. In base alle misure disposte dalla Corte dei diritti umani, le fu concesso di ricevere un cesareo alla ventiseiesima settimana di gravidanza, il che permise a Beatriz di sopravvivere. Non fu condannata per aborto, poiché teoricamente non lo era: dopo l’intervento il bambino fu messo in incubatrice, ciò nonostante morì dopo qualche ora. Il caso di Beatriz ha contribuito a cambiare il tono del dibattito pubblico, afferma Herrera. “La sua situazione e le sue richieste, e la paura che i medici ebbero nell’intervenire, erano la prova di quanto fosse assurda la situazione. Per noi c’è un prima e un dopo Beatriz, perché molte persone hanno detto che non aveva senso che non le fosse dato il permesso di porre fine alla sua gravidanza”.
Il caso di El Salvador dimostra chiaramente come una legislazione punitiva violi il diritto alla salute e all’autonomia, dissuadendo le donne dall’intraprendere cure mediche dopo l’aborto e punendo le donne per aver deciso autonomamente intorno al proprio corpo. Gli Stati dovrebbero rispettare i diritti delle donne alla salute sessuale e riproduttiva, rimuovendo le legislazioni che criminalizzano l’aborto, e garantendo l’accesso a cure praticabili e di alta qualità.