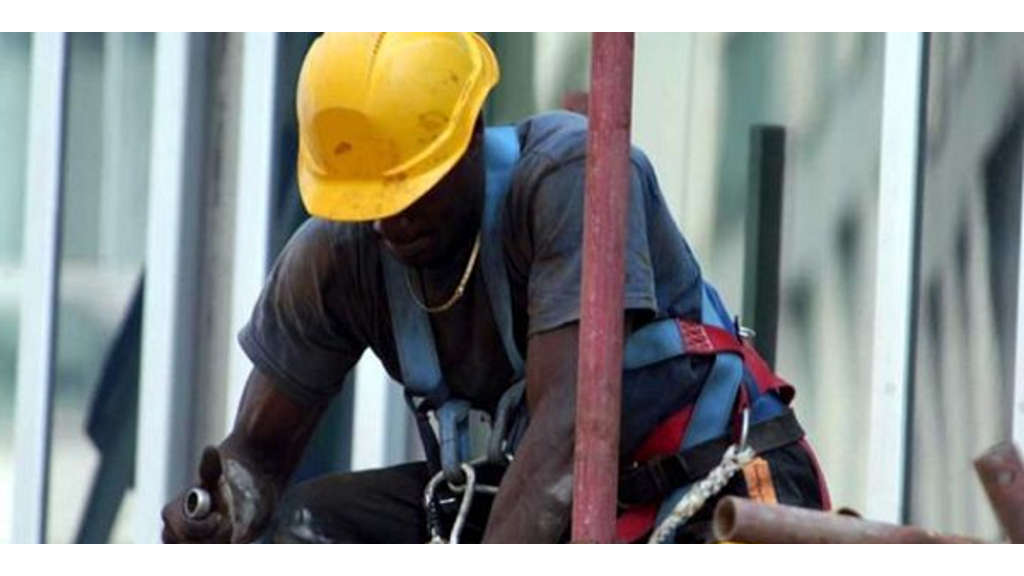
Un dibattito basato su luoghi comuni e disinformazione. Si può sintetizzare così una discussione politica che data da quel 7 marzo del 1991, giorno in cui l’Italia scoprì di essere una terra promessa, un luogo di arrivo e passaggio di immigrati. Sulle navi che sbarcarono a Brindisi non c’erano più i nostri nonni emigranti, ma migliaia di albanesi in fuga dal loro paese. Si parlò di esodo biblico, almeno diciottomila persone. Era la prima volta dell’Italia dal punto di vista degli sbarchi di massa, ma quelle non erano le prime persone ad arrivare.
Già dalla metà degli anni Settanta il sistema produttivo italiano ha cominciato ad attirare manodopera straniera (anche contro le conquiste delle lotte operaie). In particolare nelle aree più industrializzate si cominciarono a registrare i primi insediamenti. All’inizio degli anni Ottanta già si parlava di una immigrazione di lavoratori egiziani che venivano impiegati nei cantieri edili in Emilia e nelle fonderie di Reggio Emilia. Risale al 1987 la prima sanatoria sul “Trattamento dei lavoratori immigrati extracomunitari”. A marzo di quell’anno si presentarono agli sportelli delle questure almeno cinquantamila stranieri. Gli immigrati già lavoravano in molti settori, svolgevano mestieri ormai abbandonati dagli italiani (in agricoltura soprattutto). Ma nell’immaginario, dopo lo sbarco degli albanesi, l’immigrato sarebbe stato assimilato per sempre al profugo e all’invasore.
Effetti ottici
Sono due gli elementi fondamentali alla base di questa distorsione ottica. In Italia, nelle politiche migratorie, sono sempre stati assenti elementi di informazione scientifica sui fenomeni strutturali in corso (salvo ovviamente le ricerche delle Università e delle Ong). Ma è mancata di conseguenza soprattutto qualsiasi forma di programmazione. La disinformazione è stata involontaria e volontaria al tempo stesso. Basti pensare che per la propaganda della destra gli immigrati sono quelli che arrivano con i gommoni, sono le tragedie in mare, gli annegamenti, le immagini televisive. Ma solo a guardare i dati del 2019 ci si accorge dello scarto numerico tra i meno di undicimila migranti arrivati via mare e i 261mila nuovi residenti stranieri provenienti dall’estero per altre vie.
L’immigrato continua a far paura e viene usato a fini elettorali, anche se la situazione è molto cambiata dagli anni Ottanta. Nel 2020, per esempio, c’è stato un mutamento da non sottovalutare. Per la prima volta dopo un lungo periodo, infatti, la presenza straniera non ha contribuito, o ha contribuito in maniera marginale, ad arrestare il declino demografico italiano in atto dal 2015. Il tema è quello della bassa natalità italiana, con un bilancio demografico in netta decrescita. A fine 2019 la popolazione residente in Italia era calata di 189mila unità rispetto ad inizio 2019, sintomo di un costante cambiamento strutturale del contesto demografico italiano. In cinque anni l’Italia ha perso quasi 551mila residenti. E a questi numeri dovremmo ora aggiungere quelli delle morti da Covid.
Gli stranieri al lavoro
Secondo il Rapporto del ministero del Lavoro, la popolazione straniera in età da lavoro (15-64 anni), nel 2019, era pari a più di quattro milioni e 33mila individui. Gli occupati di 15 anni e oltre erano 2.505.186, le persone in cerca di lavoro 401.960 e gli inattivi tra i 15 e i 64 anni 1.175.059. Con riferimento alle variazioni registrate nel biennio 2018-2019, si osserva un aumento del numero di occupati italiani di quasi 95mila unità nell’arco di dodici mesi (in termini percentuali +0,5%), contestualmente a un incremento del numero di occupati stranieri Ue (+14.450 unità, pari a +1,8%) ed extra Ue (+35.734 unità, equivalente a +2,2%), per complessivi +144.917 lavoratori.
L’incidenza percentuale dei lavoratori comunitari ed extracomunitari, sul totale degli occupati, era – sempre nel 2019 – pari al 10,7%, sostanzialmente invariata rispetto all’anno precedente, con rilevanti differenze settoriali: nel caso dell’agricoltura la forza lavoro straniera corrisponde al 18,3% del totale, nel settore alberghiero e della ristorazione è pari al 17,7%, così come nelle costruzioni (17,6%). Nei servizi collettivi e personali, com’è noto, la presenza di lavoratori non nativi è elevata: nel 2019 l’incidenza percentuale è pari al 36%, con una preponderanza di forza lavoro extracomunitaria.
Con riferimento al carattere dell’occupazione, circa l’87% dei lavoratori stranieri svolge un lavoro alle dipendenze. L’area del lavoro autonomo è in contrazione solo nel caso degli italiani (-0,3%); di contro, positivo è il tasso di variazione dei lavoratori indipendenti extra Ue (+3,6%). Il lavoro dipendente è cresciuto in egual misura per i lavoratori stranieri Ue ed extra Ue, con una variazione tendenziale pari al +1,9%. In espansione è soprattutto il lavoro dipendente a termine degli stranieri extra Ue, cresciuto del 5% su base tendenziale; significativo è anche l’incremento del numero dei lavoratori comunitari impiegati a tempo indeterminato, con una variazione tendenziale pari a +1,9%
Con riferimento alla posizione professionale, si osserva come gli occupati stranieri si concentrino prevalentemente su profili esecutivi. Scarsa, infatti, è la presenza di lavoratori stranieri tra i ruoli dirigenziali e simili: appena l’1,1% degli occupati ha una qualifica di dirigente o quadro a fronte del 7,6% della controparte italiana e il 77,1% è impiegato con la qualifica di operaio (nel caso degli occupati nativi si tratta del 31,7% del totale considerato).
Trent’anni di Pil “immigrato”
Secondo un rapporto del 2020 della Fondazione Leone Moressa, i lavoratori stranieri contribuiscono oggi al 9,5% del prodotto interno lordo. Dalle stime relative ai dati economici e sociali del 2019, abbiamo già visto sopra che gli occupati stranieri regolari in Italia erano circa 2,5 milioni, con un aumento negli ultimi dieci anni di 600mila unità (+31% dal 2010). Anche il Rapporto Moressa conferma i dati del ministero del Lavoro. Quella immigrata è un’occupazione concentrata prevalentemente nelle professioni meno qualificate. I lavoratori stranieri sono prevalentemente uomini (56,3%) e sette su dieci hanno un’età compresa tra 35 e 54 anni. Oltre la metà ha come titolo di studio la licenza media, mentre solo il 12% è laureato. Il valore aggiunto generato dai lavoratori stranieri è pari a 146,7 miliardi di euro, pari 9,5% del Pil. Valore ridimensionato da presenza irregolare, lavoro nero e poca mobilità sociale.
Ma gli immigrati che lavorano e contribuiscono alla crescita del Pil italiano non hanno poi tante soddisfazioni. Sono ancora esclusi dal settore pubblico e raramente assunti come impiegati anche nel privato; assicurano però una componente sempre più ragguardevole del lavoro manuale ed esecutivo necessario per far funzionare molte attività produttive e di servizio: dall’agricoltura ai cantieri edili, dai ristoranti delle città agli alberghi delle zone turistiche, dalle fabbriche del made in Italy ai magazzini della logistica, dalle imprese di pulizia alle bancarelle dei mercati, dalle residenze per anziani agli ospedali che mancano di personale infermieristico e ausiliario. E ovviamente di tutto il settore dell’assistenza domiciliare degli anziani e della cura della persona.
Rubano il lavoro?
La crisi, soprattutto dopo la pandemia, non guarda in faccia a nessuno. E così le statistiche raccontano di un peggioramento della condizione occupazionale dei cittadini comunitari. Una conferma arriva anche dal tasso di disoccupazione. Quello relativo agli italiani è in continua crescita (ormai circa il 14%). Quello degli immigrati è più lento ma esiste: tredici punti percentuali. Nelle statistiche (quelle del dossier annuale sull’immigrazione, per esempio) scopriamo anche la distribuzione della forza lavoro immigrata nel mercato del lavoro italiano: il tasso di occupazione più alto è quello dei lavoratori filippini (80,4%), seguiti dai cinesi (75,5%) e dai peruviani (70,7%). Ci sono poi i moldavi (68,3%), gli srilankesi (66,7%), gli ecuadoriani e gli ucraini (per entrambi il 65,0%). Nonostante queste cifre e questa partecipazione al mercato del lavoro italiano, anche tra gli immigrati serpeggia la disoccupazione, in particolare in certe comunità. Il tasso di disoccupazione più alto si registra tra i marocchini (23,0%), i ghanesi (20,9%), i tunisini (19,6%). Anche gli albanesi e i pakistani non stanno messi bene, con un 15,2% e 14,5% rispettivamente. Per la comunità marocchina si registra anche il valore più elevato del tasso di inattività (42,5%), molto alto anche per pakistani (38,5%) e indiani (38,3%).
Pagano le tasse e i contributi
I contribuenti stranieri in Italia sono 2,29 milioni e nel 2019 hanno dichiarato redditi per 29,08 miliardi e versato l’Irpef per 3,66 miliardi. Sommando addizionali locali e contributi previdenziali e sociali, si arriva a 17,9 miliardi. Oggi il saldo tra entrate (Irpef, Iva, contributi) e costi (scuola, sanità, pensioni) dell’immigrazione è ancora positivo (+500 milioni). Gli stranieri sono giovani e incidono poco su pensioni e sanità, principali voci della spesa pubblica. Ma i lavori poco qualificati e la poca mobilità sociale possono portare nel lungo periodo a un saldo negativo. È questo almeno il quadro che emerge dalla lettura del decimo Rapporto Moressa.
Rosarno, una ferita sempre aperta
“Dopo 10 anni non è cambiato niente. Solo che non c’è più la baraccopoli. Ma i ragazzi vivono sempre allo stesso modo”, aveva scritto l’Avvenire in occasione del ricordo della rivolta di Rosarno, nel gennaio 2010. La terribile e disumana baraccopoli di San Ferdinando, dove vivevano più di duemila persone, è stata smantellata il 6 marzo 2019, ma nulla è stato fatto per dare un’accoglienza degna ai lavoratori immigrati che comunque continuano ad arrivare per la raccolta degli agrumi.
Neppure la pandemia ha fatto cambiare le cose. Ecco che cosa si legge nell’ultimo rapporto di Medu, Medici per i diritti umani, a proposito della Piana di Gioia Tauro. Sfruttamento lavorativo, difficoltà di accesso ai diritti fondamentali e ai servizi territoriali, inerzia delle istituzioni, precarietà delle condizioni giuridiche e di vita, illegalità diffusa, passività della politica, rappresentano ancora una volta i tratti distintivi della stagione di raccolta degli agrumi nella piana di Gioia Tauro, resa ancor più critica dagli effetti della pandemia da Covid-19 sulla vita dei braccianti. Fino al mese di marzo del 2019, quasi duemila persone vivevano in un insediamento di baracche nell’area industriale del Comune di San Ferdinando. Il 6 marzo 2019 l’enorme baraccopoli è stata rimossa con un’imponente operazione di sgombero voluta dall’allora ministro degli Interni, Matteo Salvini, e sostituita da un’ennesima tendopoli (la prima risale al 2013) con un numero di posti nettamente inferiore rispetto alle presenze effettive sul territorio e riservati esclusivamente alle persone in regola con il soggiorno.
Nella stagione agrumicola 2019-2020, la nuova tendopoli ospitava 440 persone (meno di un quarto dei braccianti che abitavano nella baraccopoli). Lo sgombero ha pertanto costretto centinaia di braccianti a spostarsi in altri territori o a disperdersi in insediamenti ancor più precari nelle campagne dei comuni limitrofi. Com’è tipico nelle politiche di destra, si mette tutto sotto il tappeto o si spostano i problemi altrove. D’altra parte si fa finta di non vedere alcuni fenomeni emergenti, come l’aumento dello sfruttamento, la violenza nei confronti di lavoratori immigrati, la comparsa di nuove forme di caporalato. Ne abbiamo già parlato in un altro articolo uscito su “terzogiornale”.
Il dilemma che lacera la sinistra
“Rompere la simmetria (‘accogliamoli tutti’ vs. ‘non accogliamo nessuno’) significa stabilire alcuni principi e definire una politica che dica dei ‘sì’, dei ‘no’, e soprattutto dei ‘come’. È dentro il ‘come’ che una strategia riformista può innestare una politica dell’immigrazione graduale, accogliente e che non porti a scarti dei diritti per nessuno. Non è facile, naturalmente, ma non ci sono altre strade”. Lo ha scritto in un suo blog Antonio Preiti (economista del Censis).
“L’etica della convinzione – sostiene Preiti – se usata in maniera esclusiva porta i partiti che la sostengono a ottenere solo il consenso dei convinti (che difficilmente raggiungono la maggioranza, tanto più se l’asticella si sposta sempre più in alto), mentre l’etica della responsabilità può avere il voto di tutti (gli unici che potenzialmente non la sosterranno sono solo quelli che hanno convinzioni opposte; nel nostro caso razzisti, ecc.). Se una strategia dettata solo dalle convinzioni porta alla vittoria dell’avversario, gli interessi di quanti sono i beneficiari diretti della convinzione saranno certamente meno forti e difesi. È difficile eludere la combinazione di queste cose”.
In questi trent’anni, dalla grande invasione degli albanesi del 1991 – il nostro Muro di Berlino (o meglio di Brindisi) –, la sinistra non ha fatto che dividersi al suo interno, e sulla scena mediatica si sono scontrate culture laiche e cattoliche con la Chiesa di Roma che spesso ha occupato spazi tipicamente di sinistra in tema di accoglienza e solidarietà. Nei movimenti e nei partiti non si è andati oltre alcune facili rappresentazioni. In decine di riunioni ci si è scontrati tra fautori dell’accoglienza totale e senza condizioni e promotori di una richiesta di programma dei flussi politica e sociale. Il nodo non si è mai sciolto e ha prodotto anche alcune aberrazioni e contraddizioni quando uomini di sinistra hanno avuto le leve del comando. Esempio tipico è stato l’ex ministro Minniti.
Ma il tema del rapporto tra cultura della sinistra e immigrazione merita un approfondimento. È stato così determinante nel dibattito culturale ed elettorale che non possiamo liquidarlo con facili battute o classifiche dei migliori e dei peggiori. Ci vuole un’analisi che “terzogiornale” ha cominciato ad avviare con gli articoli di Rino Genovese e Riccardo Cristiano. Dovremmo farlo anche dal punto di vista dei nuovi rapporti tra “nativi” e immigrati all’interno delle classi lavoratrici, delle nuove forme di solidarietà, del senso delle comunità e dell’integrazione possibile. Una questione non facile né dal punto di vista sociale, né dal punto di vista teorico. Se si dovesse applicare una delle categorie marxiane, quella dell’esercito industriale di riserva, che cosa potremmo dire oggi della nuova economia delle piattaforme e dell’algoritmo?













