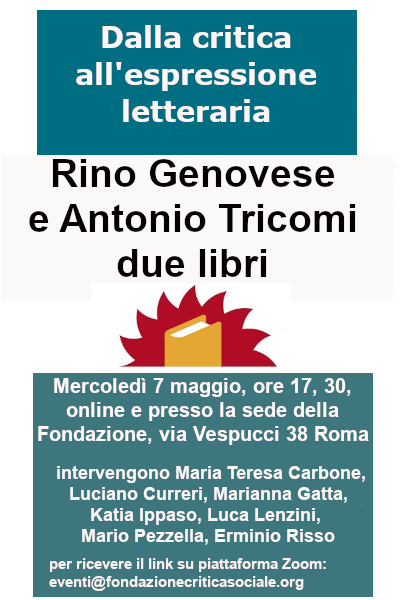“Sovrano è chi decide sullo stato di eccezione” – citazione da Carl Schmitt. Oppure: “Io so’ io e voi nun siete un cazzo” – famosa frase del marchese del Grillo. Scelga il lettore quale sia la fonte di ispirazione più appropriata per la decisione di Ursula von der Leyen, presidente della Commissione europea, di fare ricorso all’articolo 122 del Trattato europeo (Tfue) per evitare di sottoporre formalmente all’esame del parlamento europeo il suo piano di riarmo ReArmEU, poi ribattezzato Readiness2030 (“Prontezza2030”), con più spiccata sensibilità alle esigenze del marketing politico. Si tratta di una procedura d’urgenza, che elude la consultazione dell’assemblea democraticamente eletta in rappresentanza dei cittadini dell’Unione, e restituisce di fatto il potere decisionale ai governi dei ventisette Stati membri.
La commissione Affari giuridici dell’europarlamento (Juri) ha approvato, anche con i voti dei parlamentari che sostengono von der Leyen, una relazione che condanna la forzatura dell’iter procedurale. Dopo la fragorosa bocciatura, un portavoce dell’esecutivo di Bruxelles ha giustificato la scelta di von der Leyen, parlando di “serio rischio sulla sicurezza”, e ha rivendicato il fatto che “nelle sue linee guida la presidente aveva specificato che l’uso dell’articolo 122 sarebbe stato effettuato solo per circostanze eccezionali come quelle in cui ci troviamo”. Portavoce non ignaro, evidentemente, della lezione del nobiluomo interpretato da Alberto Sordi nel classico film firmato da Mario Monicelli.
Cosa succederà, quindi, dopo questo voto della commissione parlamentare? Forse nulla, dal momento che i prossimi passaggi sono nelle mani di un’esponente dei popolari europei al pari di von der Leyen, la presidente dell’eurocamera, Roberta Metsola, che dovrà riferire in plenaria sul voto in commissione Juri e, teoricamente, potrebbe anche proporre di attivare un ricorso alla Corte di giustizia dell’Unione. In effetti, in democrazia, non dovrebbe esserci un futuro per un provvedimento che passa con una procedura dichiarata illegale, o quantomeno irregolare, dal parlamento. In concreto, bisognerà però attendere per vedere se la vicenda porterà con sé degli strascichi politici o giuridici.
Eppure il sito del parlamento europeo spiega che il Trattato di Lisbona “ha conferito nuovi poteri legislativi al Parlamento europeo e lo ha posto alla pari con il Consiglio dei ministri nel decidere i compiti dell’Unione e in che modo spendere i soldi. Esso ha anche cambiato il modo in cui il Parlamento lavora con le altre istituzioni e ha dato alle deputate e ai deputati maggiore influenza su chi guida l’Unione. Tutte queste riforme hanno fatto sì che, esprimendo il loro voto alle elezioni europee, le cittadine e i cittadini avranno più voce in capitolo sulla direzione da imprimere all’Unione”.
Difficile sottrarsi alla sensazione che in alcune stanze dei vertici continentali questa visione dell’equilibrio fra i poteri non sia del tutto condivisa, visto che per un piano finanziario e industriale, che si dichiara proiettato sul 2030 – una circostanza un tantino diversa dal recente, drammatico precedente dell’emergenza pandemica – non si trova tempo né modo di coinvolgere i parlamentari. In un recente studio pubblicato dall’europarlamento sull’uso dell’articolo 122, in conseguenza degli eventi legati alla pandemia, veniva sottolineato che il Consiglio europeo “non ha sufficientemente motivato il proprio ricorso all’articolo 122 Tfue alla luce della formulazione ‘fatta salva ogni altra procedura prevista dai trattati’”, e si richiedeva “una procedura legislativa speciale che conferisca al Parlamento il potere di approvazione”. A dimostrazione del fatto che il tema degli equilibri interni alla costruzione europea non è nuovo.
Il tema qui in discussione non è il merito del piano da ottocento miliardi, destinato soprattutto a rianimare la boccheggiante industria teutonica e, almeno in parte, a placare l’aggressività antieuropea della nuova amministrazione statunitense, dato che al netto delle buone intenzioni sul buy European, una quota degli aumenti di spese per la difesa fluirà comunque nelle casse delle industrie americane. Un piano – e questo è un punto politico tutt’altro che secondario – rispetto al quale la maggioranza che sostiene l’attuale Commissione ha già messo nero su bianco il suo generico gradimento in una recente risoluzione sulla postura geopolitica dell’Unione europea, votata a maggioranza dal parlamento di Strasburgo.
Perché allora forzare gli equilibri procedurali contraddicendo il molto propagandato spirito del Trattato di Lisbona? Una possibile indicazione per comprendere l’irruenza procedurale della presidente von der Leyen, la troviamo nella presa di posizione del Fondo monetario internazionale, che, negli scorsi giorni, ha chiesto agli Stati europei di “dimostrare un forte impegno per la sostenibilità e la prudenza di bilancio”, anche di fronte alle “nuove esigenze di spesa, per esempio nell’ambito della difesa”. Tradotto: le spese militari vanno compensate o con tagli sulle altre voci di bilancio o con inasprimenti fiscali. Del resto, la strada era stata indicata qualche mese fa dal segretario generale della Nato, Mark Rutte, in una conversazione con la direttrice del Carnegie Europe, Rosa Balfour: “So che spendere di più per la difesa – aveva ammesso – significa spendere meno per altre priorità. Ma è solo un po’ meno. In media, i Paesi europei spendono facilmente fino a un quarto del loro reddito nazionale per pensioni, sanità e sistemi di sicurezza sociale”. Solo un po’ meno. Un po’ meno modello sociale europeo (peraltro reduce da trent’anni di erosione, per usare un eufemismo), un po’ meno democrazia.