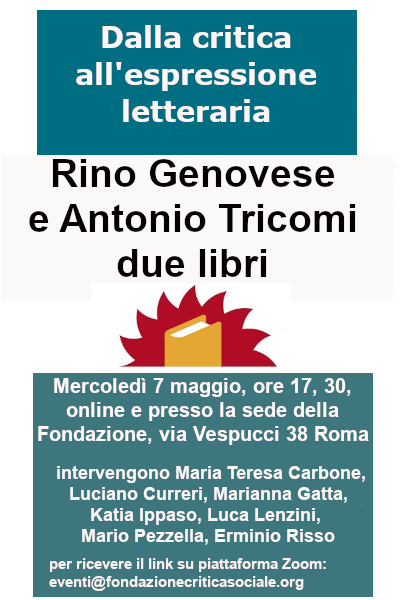Il segretario di Stato americano, Marco Rubio, e l’inviato speciale di Trump per la politica estera, Steve Witkoff (che ormai sembra avere assunto un ruolo chiave nell’amministrazione, simile a quello di Kissinger con Nixon), hanno disertato il vertice di Londra dei cosiddetti “volenterosi” (la Gran Bretagna in prima fila, a cui si accodavano Francia e Germania), facendolo fallire. Rubio ha motivato la sua defezione con l’atteggiamento del presidente ucraino Zelensky, che ha respinto il piano di pace proposto da Trump. A quanto si sa, tale piano prevede: 1) un cessate il fuoco “duraturo”; 2) il riconoscimento de iure della sovranità russa sulla Crimea e de facto di quella sul Donbass; 3) la rinuncia all’ipotesi di adesione dell’Ucraina alla Nato. Nel caso di una rapida accettazione di tale piano da parte del Cremlino, gli Stati Uniti sarebbero disposti ad allentare le sanzioni economiche imposte alla Russia.
Che Zelensky, almeno in questa prima fase, avrebbe respinto il piano era abbastanza scontato: il presidente ucraino ha infatti più volte ripetuto che il suo Paese non intende cedere parti del territorio; e questo rende immediatamente inaccettabile il punto 2. Questa rigidità contrasta, almeno in parte, con l’atteggiamento da lui tenuto in occasione dei negoziati di tre anni fa in Turchia, poi falliti. Infatti, come si è più volte ricordato su “terzogiornale”, in quell’occasione la dirigenza ucraina si era mostrata disponibile a cedere Crimea e Donbass alla Russia, nonché a rinunciare all’adesione alla Nato. La causa fondamentale del fallimento delle trattative di allora fu il mancato raggiungimento della garanzia per l’Ucraina di essere protetta da eventuali nuove aggressioni russe.
“Una simile garanzia non è assicurata neppure dal piano proposto da Trump”, osservano K. Barker e M. Varenikova sul “New York Times” del 24 aprile, senza entrare nei dettagli, ma l’osservazione appare corretta. Infatti, finora si è parlato soltanto, e genericamente, della dislocazione di truppe dei Paesi dell’Unione europea sul territorio ucraino e di una forza di interposizione al confine tra l’Ucraina e la Russia, composta da Paesi terzi. In ogni caso, la mancanza di chiarezza da parte dell’amministrazione Trump su questo punto cruciale può senz’altro spiegare l’atteggiamento di Zelensky.
Tuttavia, tale atteggiamento è probabilmente dovuto anche a problemi di politica interna. Occorre quindi ricostruire brevemente la parabola politica di Zelensky. Inizialmente eletto con un programma abbastanza conciliante nei confronti della Russia (e per questo inviso alle forze ucraine più oltranziste, le cui simpatie filonaziste non vanno esagerate, ma certamente nemmeno trascurate) e preso alla sprovvista dall’attacco russo del 24 febbraio 2022, ha poi conquistato un largo favore popolare con la sua condotta coraggiosa (rifiutò l’offerta di Biden di lasciare Kiev per espatriare in un luogo sicuro) e con l’incitamento alla resistenza contro l’invasore, che indubbiamente ha avuto successo nei primi mesi di guerra. Per questo, esattamente tre anni fa, poteva permettersi di prospettare concessioni territoriali a Putin senza rischiare di essere rovesciato. Poi, anche per l’incoraggiamento di Boris Johnson e Biden, quando il negoziato è entrato in stallo per il mancato accordo sulla clausola di garanzia, ha ritenuto possibile continuare la guerra contro la Russia escludendo qualsiasi ipotesi di negoziato.
D’altra parte, per potere continuare a resistere, l’Ucraina ha bisogno in modo decisivo del sostegno militare americano, che ora Trump minaccia di cancellare (in questo momento tali aiuti sono ridotti, ma non completamente aboliti). Sotto questo aspetto, c’è da tenere conto del fatto che, a quanto pare, Zelensky sarebbe ormai disposto ad accettare l’accordo proposto da Trump per compensare l’aiuto americano con la fornitura di minerali, in particolare “terre rare”. In un articolo pubblicato sul “New York Times” del 20 aprile, a firma Kim Barker, si legge: “Secondo gli analisti, l’accordo sui minerali, se firmato, potrebbe dare all’Ucraina una sorta di leva per ottenere più armi dagli Stati Uniti o quantomeno continuare a ricevere informazioni di intelligence militare dagli Stati Uniti”.
Da parte del Cremlino, a parole, si mostra una certa apertura al negoziato, con varie dichiarazioni di apprezzamento nei confronti della politica di Trump, ma sempre con una tattica piuttosto dilatoria (“i problemi da affrontare sono molti e complessi”: così si potrebbe riassumere il succo delle dichiarazioni del portavoce Peskov e di altri politici). Putin cerca di sfruttare la situazione militare a lui ormai decisamente favorevole, contrariamente a tre anni fa, per potere arrivare al tavolo delle trattative in una posizione di forza. Anche gli ultimi attacchi su Kiev, che hanno fatto varie vittime civili, si collocano in questa strategia. Come si sa, Trump ha reagito gridando “Vladimir, fermati!”, ma questa sembra più una strategia mediatica che altro: le preoccupazioni umanitarie non affliggono eccessivamente il presidente americano, che non ha mai speso una sola parola per compiangere i palestinesi uccisi a Gaza, in proporzione molti di più dei soldati e dei civili ucraini che hanno perso la vita nel conflitto in corso. Trump, da bravo commerciante, vuole concludere affari vantaggiosi: quello con l’Ucraina sui minerali può rivelarsi tale, ma forse spera di concluderne uno ancora più conveniente con la Russia. Quale? Forse un appoggio all’occupazione della Groenlandia: ma qui si entra nel campo delle pure speculazioni, a cui è meglio non abbandonarsi.
In ogni caso, l’arbitro della situazione è, al momento, certamente Trump: l’Ucraina, come si è detto, non può rinunciare al sostegno militare americano. E anche gli stessi Paesi “volenterosi” sanno benissimo che non possono, da soli, sostituirlo: se così fosse, non avrebbero ridotto l’incontro di Londra, mercoledì 23 aprile, a un semplice scambio di idee tra alcuni tecnici. Cosa guida la politica di Starmer, Macron e Merz (non ancora cancelliere, ma lo sarà tra poco)? Stando a un altro articolo del “New York Times” del 24 aprile – a firma di S. Erlanger e significativamente intitolato Se l’America si ritira dall’Ucraina, cosa farà l’Europa? – per l’Europa “è in gioco il principio fondamentale della sicurezza europea da oltre cinquant’anni: i confini internazionali, indipendentemente da come siano stati tracciati dopo la fine della Seconda guerra mondiale, non devono essere modificati con la forza”.
Quindi, l’Unione e gli altri Paesi del continente (in primo luogo, la Gran Bretagna) non possono per principio accettare il riconoscimento de iure dell’annessione della Crimea e di altri eventuali territori ucraini alla Russia. Di conseguenza – prosegue Erlanger – l’obiettivo dell’Europa “è consentire a Kiev di negoziare autonomamente una fine accettabile della guerra, con un’assistenza e garanzie di sicurezza sufficienti a scoraggiare la Russia nel futuro, idealmente con l’aiuto finanziario e militare americano, ma, se necessario, anche senza”.
Ci si può domandare, però, come si può raggiungere, realisticamente, tale obiettivo? Certamente non confidando nel piano di riarmo dell’Europa (o comunque lo si voglia chiamare) che, come riconosciuto dai suoi stessi proponenti, potrebbe essere completato solo nel 2030. Entro quella data, Putin potrebbe essersi impadronito dell’intera Ucraina, e, stando alla narrativa corrente in molti media, anche dei Paesi baltici e di altri Paesi Nato, in primo luogo della Polonia. Probabilmente, gli attuali governanti “volenterosi” sperano che un’iniziativa del genere porti all’intervento statunitense, in base all’art. 5 dello statuto della Nato, al quale Trump dovrebbe tener fede. Oppure, sperano che l’Ucraina, con l’eventuale aiuto delle loro truppe, possa continuare a resistere alla Russia fino al completamento del piano di riarmo o fino a un nuovo capovolgimento della politica americana, che potrebbe realizzarsi se alle elezioni presidenziali del 2028 vincessero o un candidato democratico, o uno repubblicano contrario alla politica di Trump.
Un altro articolo, pubblicato il 24 aprile, sull’autorevole quotidiano newyorkese, di M. Crowley, suggerisce uno scenario più ottimistico. Riporta, infatti, questa opinione di Daniel Fried, “ex diplomatico con una vasta esperienza di Ucraina e di Russia”: “È perfettamente ragionevole accettare la realtà che per un periodo di tempo indefinito alcune parti dell’Ucraina saranno sotto l’illegale occupazione russa”, mentre “è tutt’altra cosa riconoscere ufficialmente un cambiamento di confine con la forza”. Più avanti, nello stesso articolo, si ricorda che anche Trump si è espresso almeno una volta in questo senso, scrivendo che “nessuno chiede a Zelensky di riconoscere la Crimea come territorio russo”. L’articolo prosegue così: “Alcuni analisti ritengono che Zelensky e i governanti europei potrebbero tollerare una simile posizione degli Stati Uniti, per quanto possano essere in disaccordo, se non vengono spinti ad approvarla”. Si tratterebbe, quindi, di una soluzione simile a quella adottata per le alture del Golan, occupate da Israele nel 1967 dopo la guerra dei sei giorni e unilateralmente annesse qualche anno dopo, senza però che l’annessione fosse riconosciuta dalla comunità internazionale.
Basterebbe dunque, per arrivare a una composizione del conflitto, una semplice correzione al “piano di pace” di Trump, che trasformi il riconoscimento de iure della sovranità russa sulla Crimea in una semplice constatazione di fatto? C’è da essere abbastanza scettici, in primo luogo perché rimarrebbe aperta quella che continua a essere la questione fondamentale, cioè il raggiungimento di un accordo che garantisca la sicurezza dell’Ucraina in una forma accettabile anche per la Russia, cioè escludendo comunque l’adesione dell’Ucraina alla Nato (vedi qui). In ogni caso, se così fosse, il programma di riarmo dell’Unione si rivelerebbe ancora più grottesco, perché sostanzialmente inutile (salvo giovare alla ripresa economica della Germania, grazie alla riconversione di buona parte dell’industria tedesca da meccanica a bellica).