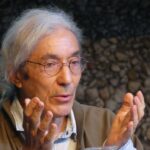Una decina di giorni fa, la conquista di Goma (vedi qui), nel nordest della Repubblica democratica del Congo, in una regione ricchissima di cobalto, da parte del gruppo M23 appoggiato dal vicino Ruanda, ha confermato una volta di più il ruolo che hanno i minerali strategici nella nuova corsa all’Africa. La transizione energetica (i pannelli solari, le pale eoliche, i veicoli elettrici, così come i touch screen e le connessioni tra sistemi) porta in primo piano la necessità di procurarsi alcuni tipi di minerali, di cui l’Africa è particolarmente dotata. Così la domanda mondiale è in rapido aumento, mentre il continente non ha ancora sfruttato tutte le sue potenzialità.
Il primo produttore mondiale di cobalto e di tantalio è il Congo; il rame, formidabile conduttore di elettricità, e quindi indispensabile per i cavi e in parte per le batterie, vede lo Zambia al nono posto; il Sudafrica e il Gabon sono ai primi due posti per il manganese, mentre il Ghana è al quarto. Il primo produttore di platino, indispensabile per l’idrogeno verde, è il Sudafrica, seguito dallo Zimbabwe al terzo. Il Mozambico è al secondo posto per il titanio, seguito dal Sudafrica, che è al terzo posto anche per il vanadio. La Guinea al secondo posto per la bauxite (alluminio) e, come il Marocco, per la fosforite (fertilizzanti). Complessivamente, l’Africa è al primo posto tra i produttori mondiali di quattro minerali strategici: cobalto, manganese, cromo e platino. E in buona posizione per altri cinque: bauxite, grafite, rame, nickel e zinco.
Poi ci sono le riserve: si stima che l’Africa detenga il 50% delle riserve di cobalto, l’85% del manganese, il 21% della grafite. Sono percentuali da rivedere, perché l’Africa è anche il continente dove finora si è relativamente investito poco nell’esplorazione. Da questo punto di vista, si sta aprendo uno scenario del tutto nuovo con la prospettiva di nuovi investimenti nella ricerca di nuovi giacimenti. L’apporto degli investimenti stranieri è decisivo. Per questo si moltiplicano i forum economici delle potenze economiche mondiali, con i partner consolidati o solo potenziali. La Cina è senz’altro la meglio piazzata grazie a una politica di cooperazione economica lungimirante con la maggior parte dei Paesi africani, dove è presente in modo strutturale, in più settori economici, da quello delle terre agricole ai minerali, alle infrastrutture, fino alla formazione e alla ricerca. La Cina controlla attualmente oltre il 40% della produzione di cobalto africano e quasi un terzo del rame, mentre i Paesi occidentali controllano un quarto della produzione mineraria africana.
L’aumento dello sfruttamento dei minerali strategici in Africa deve però affrontare diverse sfide. La prima è quella degli investimenti economici in Paesi fortemente indebitati, che finora hanno fatto fronte al peso del debito cedendo le proprie risorse minerarie, con un sistema che ricorda – eccezione fatta per il settore degli idrocarburi – gli albori del colonialismo, e che infatti non ha lasciato margini per lo sviluppo, anzi ha impoverito e fatto aumentare le disuguaglianze nei singoli Paesi. Lo sfruttamento dei nuovi giacimenti si scontra con l’insufficienza e la fragilità delle infrastrutture, che dovranno essere enormemente potenziate e dovranno vedersela, per i Paesi che non hanno sbocco al mare, con complesse questioni geopolitiche. Non a caso, gli investitori stranieri hanno acceso i riflettori sui “corridoi”, cioè su quelle vie transfrontaliere, oggi del tutto inadeguate o ancora da attrezzare, per il trasporto dei minerali e dei beni primari, ma anche, in futuro, sulle infrastrutture indispensabili allo sfruttamento delle ricchezze.
Gli investimenti massicci a loro volta rinviano alla questione della stabilità politica. I colpi di Stato nei Paesi del Sahel, la presenza in questa stessa area e altrove, come in Somalia e in Mozambico, di movimenti jihadisti, l’attività della ribellione armata, nel caso della Repubblica democratica del Congo, sono fattori che condizionano la possibilità di investimenti. Fra l’altro, nel Sahel e nell’Africa francofona è in atto un rivolgimento di alleanze, con la partenza delle truppe francesi che sposterà anche gli equilibri economici verso i nuovi partner. I cinesi sono già presenti, e poi si tratta soprattutto della Russia, della Turchia, dell’India, inoltre di un pugno di Paesi asiatici. In questo scenario, si collocheranno anche gli Stati Uniti di Trump – e la concorrenza si annuncia spietata.
L’irrigidimento autoritario di molti Paesi africani favorirà la cooperazione “indifferente” dei partner extraeuropei – Cina, Russia – cui si aggiungerà senz’altro l’amministrazione Trump, mentre il richiamo dell’Unione europea ai principi della democrazia dei diritti umani è da tempo indebolito, e non solo con la nuova Commissione europea (cosa del resto confermata, anche in casa nostra, dal caso Almasri). Un altro fattore di rischio è la corruzione, che coinvolge tutte le realtà che danno o ricevono i flussi degli investimenti, come illustrano bene anche episodi di cronaca italiani. Non perché la corruzione impedisca gli investimenti, anzi, ma penalizza fortemente il funzionamento delle istituzioni, che democratiche non possono essere, e impedisce anche una più equa ripartizione delle ricchezze.
L’ultima sfida riguarda il modello di crescita dell’economia che sfrutta le risorse minerarie strategiche. Finora la stragrande maggioranza della produzione mineraria viene ancora esportata grezza. Da alcuni anni, le istituzioni dei Paesi africani si sono poste l’obiettivo di trasformare sul posto i prodotti minerari estratti, in modo da ottenere un valore aggiunto che fin qui è loro sfuggito. È la vera sfida dell’economia africana: quella di riconvertirsi da esportatrice di materie prime a fornitrice di prodotti finiti. Acquisteremo apparecchi ad alta tecnologia, automobili elettriche africane, magari fabbricate grazie all’intelligenza artificiale cinese? Prepariamoci ai nuovi scenari.