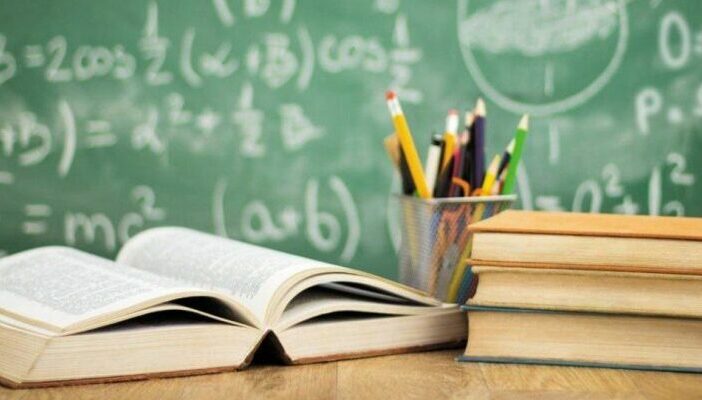
I fatti di sangue o violenza che sconvolgono l’Italia hanno spesso sollecitato come risposta la necessità di preparare ragazze e ragazzi prima che le tragedie avvengano. Non solo la grammatica delle lingue; alla scuola italiana si chiede sempre più spesso di insegnare le grammatiche della vita. Soprattutto per quanto riguarda l’educazione all’affettività e alla sessualità. Le scuole italiane godono di una certa autonomia che consente loro di sviluppare programmi e progetti di educazione all’affettività, e non sono pochi gli istituti che si avvalgono di questa facoltà per curare anche questo aspetto della formazione dei propri alunni.
Il discorso di questi giorni ribadisce che, per prevenire la violenza sulle donne, bisogna inserire nelle scuole una materia specifica dalle elementari alle superiori. Ma questi discorsi mortificano. Quanto è facile addossare alla scuola tutte le responsabilità che nessun’altra parte della società vuole prendersi! È facile, è una risposta pronta all’uso da parte di giornalisti, politici, anime belle, gente da bar: è uno svuota-tasche della coscienza collettiva. Oltretutto, la scuola e gli insegnanti in genere godono oggi di così scarsa stima che si prestano bene a fare da parafulmine per le responsabilità che un intero sistema sociale non vuole prendersi. Come si fa a pensare che la scuola possa da sola fare fronte a questa che, in molti, definiscono come un’emergenza educativa? Colui che molesta, abusa, uccide una donna in quanto donna – secondo una definizione standard, anche se imperfetta, di femminicidio – non va compreso, ma giudicato, senz’appello. “Solo stigma e condanna”. Questo tipo di approccio è tuttavia manchevole, e anche controproducente.
Non ci si rende conto che le violenze sono il sintomo di un problema sociale e culturale? C’è il consumo delle droghe, ci sono i disturbi del comportamento alimentare, e poi ci sono i suicidi e i femminicidi. Il vero problema, per tanti giovani, è la disperazione che hanno dentro e l’impotenza e la rabbia, il senso di abbandono e la certezza di non valere nulla. Le famiglie sono protese a difendere i figli a tutti i costi. Nascondono sotto il tappeto le fratture, i problemi, invocando scuse e giustificazioni. Un film recente – Educazione fisica, di Stefano Cipani – lo racconta bene. Noi adulti dovremmo davvero fare un esame di coscienza: chiederci come mai gli adolescenti, gli studenti, vivono come se fossero tutti orfani. Un ragazzo, apparentemente tranquillo e pacifico, ha ucciso la sua ex ragazza con ventisette coltellate. Ci vogliamo chiedere perché? Cosa c’è dietro un gesto così disperato?
È necessario un approccio strutturale e sistemico, impegnato cioè a ricostruire il fitto intreccio di radici che sostengono e nutrono quello che si vede in superficie. Queste radici non sono mai del tutto “naturali”, ma una rete sottostante a tutti gli ambiti di interazione sociale, fatta di regole, leggi, riti, valori, convinzioni, costrutti identitari, istituzioni. Per esempio, quelle identità tradizionali di genere – o sei uomo o sei donna (tertium non datur). Se sei uomo, devi essere indipendente, farti valere, saperti procacciare le cose che desideri a qualsiasi costo, ecc.; se sei donna, devi saperti prendere cura delle debolezze altrui, delle loro dipendenze, accondiscendere, evitare il più possibile i “no”, ecc.: tutte cose sopravvissute imperterrite alle fluidità postmoderne e neoliberali. O ancora, per esempio, la credenza – nonché abitudine pratica – per cui la libertà dell’altro sarebbe un limite alla e non una condizione per la nostra libertà. Per esempio, le idee secondo cui la gelosia, la follia, rappresentano gli indicatori positivi dell’intensità di una passione. E ancora: quelle dinamiche sociali in cui la difficoltà di lasciare il proprio aguzzino non è solo una questione di sentimenti, ma anche di sostentamento materiale o di praticità logistica. E si potrebbe continuare. L’uomo violento e femminicida non è un malato, ma la società che si riproduce (malamente) in forza di strutture di questo tipo lo è – e va cambiata.
Nella società patriarcale le relazioni sociali non sono liberamente costituite dalle parti, sono predefinite da norme e gerarchie rigide imposte dall’alto, e i sentimenti e le emozioni non possono essere liberamente espressi e vissuti, ma vanno controllati, manipolati, spesso repressi. La prossima volta che un’amica, una sorella, una parente, una madre, una collega avrà fiducia in voi e proverà a raccontarvi, magari in forme confuse, di un abuso percepito o paventato, non minimizzate, non girate il capo, per vergogna o senso di impotenza. In quella confidenza c’è il seme di qualcosa cui prestare attenzione. Con le antenne sintonizzate su sensibilità e empatia. Dimenticatevi dell’ansia di mettervi al riparo, per un momento. Quel lasso di tempo, la sospensione, lo spazio tra l’ascolto, la paura che lo impregna e subito contamina, e la reazione di rigetto e minimizzazione, può fare la differenza. Tra la vita e la morte, a volte.
Ma allora, è l’amore, nel nostro contesto patriarcale, il problema? Lo è, e non è facile da affrontare. È questo il lavoro da fare, riflettere e capire come l’amore sia (anche) qualcosa di cui vorremmo tanto fare a meno: desiderio di possesso impossibile da soddisfare e paura dell’abbandono, impossibile da cancellare del tutto. Possiamo imparare ad amare al di là del controllo, dell’ansia della perdita? Per impararlo, dovremmo però avere il coraggio di riconoscere, accogliere, e solo in seguito fare i conti con gli angoli dei nostri bisogni affettivi. I tentativi (cristianeggianti) di separare l’amore da tutto ciò che di malvagio e pericoloso abita l’animo umano sono lodevoli, ma limitati e inutili. La questione della purificazione dell’amore è parte del problema, esattamente come la cecità nei confronti della dimensione strutturale della violenza di genere.









