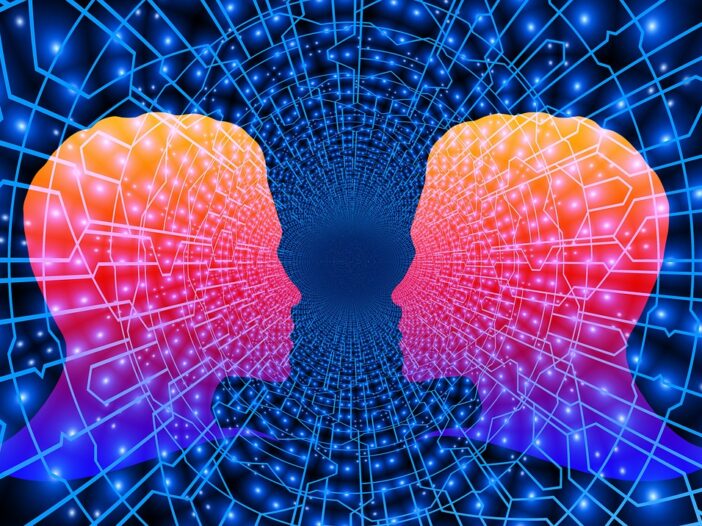
La notizia per giornali e tv è stato l’abbraccio fra Grillo e Conte, a suggellare l’ennesima tregua fra due traiettorie palesemente divergenti. Ma la sostanza della lunga e densa giornata di ascolto sull’intelligenza artificiale, organizzata a Roma dai 5 Stelle, è un cambio radicale di approccio alla materia tecnologica, e la stabilità della sua base sociale. Non si dimentichi che il tema dell’innovazione tecnologica fu una matrice fondante del movimento: tra Grillo e Gianroberto Casaleggio. Le prime campagne dell’allora popolarissimo comico con il guru digitale si basavano su una visione della tecnologia come alternativa alla politica. Casaleggio, titolare di un’agenzia di consulenza che cominciava a lavorare con grandi clienti – avendo come partner i global player del mercato, da Google ad Amazon –, teorizzava che bisognasse (nel 2008-2009) fare come fanno quelli che vincono in rete. L’intento era quello di attaccare le vecchie élite ideologiche, dalla sinistra postcomunista all’area berlusconiana e conservatrice, in nome dell’irreverente cambiamento indotto da piattaforme che ambivano a sostituirsi allo Stato. Il sogno estone era la ricetta promossa dalla strana coppia formata dal mattatore genovese e dall’enigmatico sciamano tecnologico: facciamo come in quel Paese baltico che ha appaltato tutto a Google. Tappe di quella predicazione furono i convegni Sum a Ivrea, dove Casaleggio, prendendo in ostaggio la negletta memoria di Adriano Olivetti, cercava di dare profondità alla base ideologica del nuovo movimento, combinando le proprie previsioni con il supporto dei grandi marchi della Silicon Valley che rispondevano in forze all’appello dei 5 Stelle.
Ma la repentina scomparsa di Casaleggio stronca le ambizioni di organico sviluppo di questa visione. Rimane in eredità la famosa piattaforma Rousseau, che diventa prima una clava con cui il figlio del guru, in una relazione sempre più precaria con Grillo, prova ad assicurarsi un primato nella direzione di una realtà che si espande a grande velocità, anche elettoralmente. Mentre, inevitabilmente, la piattaforma si tramuta in un ring, su cui le varie componenti si contendono il controllo del marchio.
Questo per dire che il tema “intelligenza artificiale” non è routine in casa 5 Stelle, ma sollecita e richiama i fantasmi di un passato non completamente passato. Almeno così si sarebbe potuto supporre. Invece, quanto abbiamo visto sabato 18 novembre, ci dice che i retaggi del big bang grillino sono stati abilmente resettati, e il movimento, reduce da esperienze di governo forse precoci e indigeste, si atteggia oggi all’ascolto più che alla predicazione. Nell’evento di Roma, infatti, in uno degli ambienti iconici dell’innovazione digitale, sulla via Ostiense, il tratto caratteristico è stato proprio l’ascolto, in una per certi versi bulimica voglia di darsi una visione, di acquisire una competenza, senza pregiudiziali. Diciamo una disponibilità quasi eccessiva ad assorbire suggerimenti e indicazioni da una pletora di esperti, che però inevitabilmente hanno moltiplicato i dubbi, più che chiarire le ricette.
In un allestimento smart, con una sequenza di hangar e tendoni, dove si battevano i denti dal freddo e non si cedeva un millimetro in platea, si sono combinate la ormai inevitabili mostre di aziende e prodotti destinati a stupire il pubblico, con una distribuzione di seguitissimi gruppi di lavoro. Complessivamente, millecinquecento persone, per circa dieci ore, facevano da corona a una trentina di opinion leader, chiamati a fare il punto sul tema ineludibile del momento: effetti e conseguenze dell’intelligenza artificiale.
In questa coreografia, gli organizzatori erano del tutto mimetizzati: nessun simbolo o bandiera del movimento, solo un logo, Idia, che contrassegna la serie di iniziative sull’argomento tecnologico varato da qualche mese. Unico filo conduttore un’agile e accorta conduzione di Barbara Carfagna, la giornalista del Tg1, titolare di “Codice”, unica trasmissione della Rai sui processi innovativi concreti, che ha cucito, con una logica professionale e un ritmo televisivo, la sequenza di interventi, rendendoli più pertinenti all’obiettivo: capire quale sia oggi la tendenza nel dualismo fra proprietà privata e spazio pubblico nella gestione della potenza di calcolo che automatizza la nostra vita.
Rispetto alle messe cantate di Ivrea, in cui Casaleggio orchestrava il coro dei consulenti e dei leader, vertici dei gruppi multinazionali, per narrare le “magnifiche sorti e progressive” della tecnologia, a Roma hanno dominato i tratti critici, la consapevolezza di quella relazione fra rischio e opportunità che è alla base di ogni processo innovativo. Due le caratteristiche “sociologiche” dell’evento: la selezione delle voci sul palco, e la composizione anagrafica e professionale della platea.
Gli esperti erano stati dosati con l’ambizione di rappresentare uno spaccato fedele dei punti di attrito, e non delle promesse di soddisfazione che la nuova ondata di tecnologie generative producono nelle relazioni sociali. I toni erano inevitabilmente diversi, con punte anche contraddittorie; ma si capiva che chi parlava era il testimonial di un’esperienza concreta (università, piccole e medie imprese, pubblica amministrazione, sanità, informazione, giustizia, differenze di genere, ruolo delle istituzioni). Il crinale apparso emergente è stato quello del dualismo fra etica e poteri. Ossia fra una pressante richiesta di riprogrammazione etica degli algoritmi e dei dati, che sostengono lo sviluppo dell’intelligenza artificiale, e, invece, un’accentuazione delle modalità di contestazione dei poteri esercitati dai proprietari di questi sistemi. Altro aspetto del tutto inedito, in un dibattito politico, il tema emergente dei dati sintetici. Parliamo di un problema emerso in questi giorni, riverberatosi nei ragionamenti che hanno animato il focus dei 5 Stelle: il pericolo di un imminente esaurimento dei dati esperienziali, con cui vengono addestrati i sistemi neurali delle diverse forme di intelligenza artificiale, e dei dati prodotti dagli stessi dispositivi tecnologici. Un loop cognitivo che aprirebbe, per la prima volta in maniera tangibile e organizzata, la strada alla minacciata singolarità dei sistemi tecnologici, ossia alla loro capacità di sottrarsi a un controllo sociale, sfuggendo persino ai proprietari.
Temi complessi, in parte anche pionieristici, che hanno incontrato una platea attenta. Infatti, agli occhi del cronista, l’elemento più interessante e curioso era proprio quello di cercare di capire cosa c’è nella pancia di questo movimento, che, dopo un’immersione certo non lusinghiera nelle stanze del potere, rimane tuttavia con una massa critica significativa, non distante dal seguito elettorale del Pd. Il campione trovato a Roma dà qualche indicazione per rispondere a questo quesito. Abbiamo detto di una platea che ha seguito con una certa stabilità e tenacia l’intero arco dei lavori. Anagraficamente, soprattutto un segmento di quarantenni-cinquantenni. Con una componente non residuale di ventenni e trentenni. Erano certo, in larga maggioranza, addetti ai lavori: tecnici, operatori commerciali, piccoli imprenditori, ricercatori, pubblici amministratori. Diciamo pure un fedele bonsai del popolo digitale, nella sua fascia medio-bassa. Pochi i vertici e i consulenti, che invece furoreggiavano a Ivrea, alla corte di Casaleggio. Ancora meno gli scintillanti manager tecnologici che ingolfavano la platea dell’analoga iniziativa del Pd di qualche settimana fa (vedi qui). Una platea di esecutori, di calcolati, con pochi calcolanti. Disseminati fra i banchi degli uditori, i gruppi parlamentari, i consiglieri e gli assessori di città e Regioni. Muti. Una scelta certo coerente con l’opzione dell’ascolto – ma forse sarebbe stato utile capire come si stanno muovendo, negli apparati decisionali, questi delegati.
Abbiamo visto, in sostanza, un campione sociale in cui non era difficile rintracciare tipiche origini di sinistra, ma in cui era altrettanto evidente una mutazione genetica che rende questo ceto professionale subalterno non più riducibile a una narrazione collettivo-solidaristica e piuttosto sensibile a un negoziato con le élite del momento per strappare occasionali spazi gestionali. Una forma di irredentismo culturale di ceti medi che ambiscono a contendere le gerarchie più che a rovesciarle. Un ceto disponibile su singoli problemi, dall’ambiente ai regolamenti urbani, a singole strategie industriali, ma non ad associarsi stabilmente a una politica di medio periodo. Non ci è parso di vedere “campo largo” sotto quei tendoni romani, ma solo alleanze momentanee su aspetti specifici.
Se proprio vogliamo usare categorie tradizionali, quel popolo di piccoli e medi professionisti non ha né voglia né strumenti per ritornare a forme organicistiche della politica, dove tutto si tiene, e da tempo ha scelto di separare i problemi dalle convenienze, procedendo per singole soluzioni. E infatti la giornata è apparsa squilibrata sul versante tecnico. Molte disquisizioni e comparazioni fra le sinapsi umane e quelle digitali, poche conclusioni politiche sulle forme degli interventi. La parola “regole” dilagava, ma rimaneva a mezz’aria fra la strategia dettagliata dell’Unione europea e il recente ordine di Biden (vedi qui), che ha fatto irruzione sulla scena con indicazioni prescrittive e soprattutto con l’impegno di assicurare un ruolo negoziale ai grandi utenti della rete, come i territori, le università, le imprese, la sanità.
L’unico momento in cui i padroni di casa si sono ripresi la responsabilità del palco è stato con l’intervento finale di Giuseppe Conte. Un intervento in linea con la svolta didattica del movimento: “Siamo qui per capire e imparare” – ha detto il leader, non facendo riferimenti alle origini e alla storia dei 5 Stelle, che sull’argomento, come abbiamo visto, è stata particolarmente invasiva. Conte ha provato a destreggiarsi in uno slalom fra apocalittici e integrati, cogliendo alcuni spunti – per esempio proprio la volontà del documento con cui Biden pone la centralità di un ruolo pubblico nella programmazione del mercato digitale –, che ha subito contemperato con una denuncia del pericolo di un imperialismo digitale, su cui ha raccolto applausi scrocianti da una platea che voleva celebrare le origini di lotta del movimento. Per il resto, Conte ha girato al largo, impegnandosi a proseguire nello sforzo di ascolto.
Forse uno spunto, che pure era emerso dal dibattito, andava meglio approfondito. Ci riferiamo al tema scottante dell’uno vale uno. Una bandiera servita a rottamare i professionisti della politica, aprendo la strada a una leva di parlamentari molto simili ai propri elettori. Ma che adesso si arricchisce di aspetti socio-antropologici. L’accesso universale a risorse di calcolo, tipo ChatGPT o Bard, pone con forza la questione di una nuova relazione politica e culturale fra base e vertice, fra governanti e governati, una nuova idea di partito, e di istituzioni, in cui ogni individuo si trova ad avere – automaticamente potremmo dire – capacità e competenze affini, se non simili, a quelle dei suoi vertici. Riaprire una riflessione sul rapporto fra delegato e delegante sarebbe il miglior antidoto per dare alla politica la nobiltà di traino, e non affannato inseguitore, di una tecnica che rischia di suggellare sempre più il primato di pochi proprietari. Ma questo sarebbe stato davvero chiedere troppo a una platea uscita esausta da una giornata stressante.









