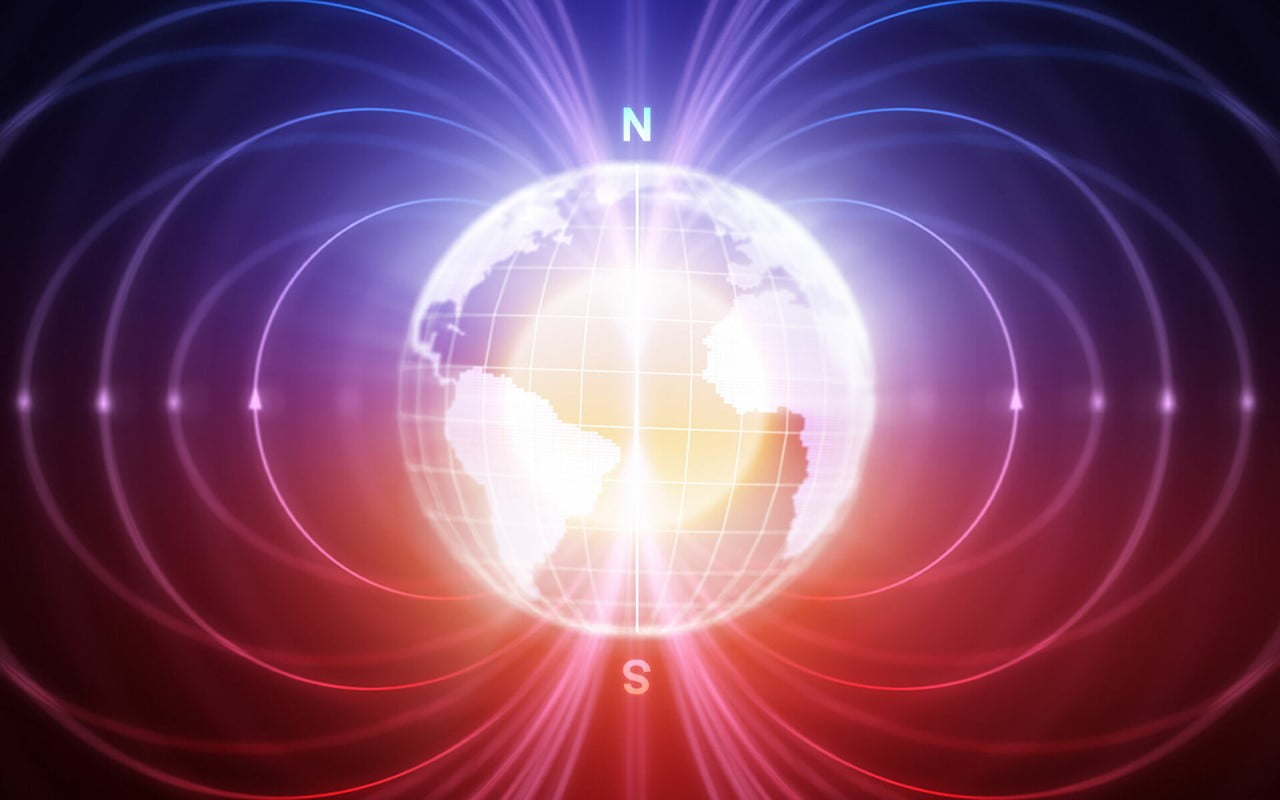
Reverse flow: sembra questa la formula destinata a caratterizzare il prossimo dibattito post-elettorale e soprattutto a identificare la nuova natura del sistema produttivo nazionale rispetto all’evoluzione europea. Reverse flow, o “flusso inverso”, è il termine con il quale si identifica il processo che rovescia il condotto degli oleodotti. Come spiega in una recente intervista su “Repubblica” Michael Stoppard, vicepresidente di S&P, l’agenzia di analisi delle strategie degli approvvigionamenti energetici globali, “al momento le pipeline sono state concepite per trasportare gas e petrolio da nord a sud e da est a ovest, ma possono essere riprogrammate e invertire il ciclo”.
Questa opportunità renderebbe plausibile la strategia che era stata definita dal governo Draghi: costruire un’intelaiatura di alleanze e forniture capace di rendere il nostro Paese il nuovo hub di raccolta e smistamento dei flussi energetici dall’Italia verso i Paesi nordeuropei, emancipando l’intero continente dalla dipendenza dalla Russia. Una strategia dagli evidenti risvolti geopolitici che – fa intendere Stoppard – potrebbe non essere estranea alla decisione di far cadere l’esecutivo di Draghi, presa proprio dalle forze più vicine al Cremlino.
La partita sul ruolo dell’Italia, nella nuova geografia degli oleodotti, annuncia una trasformazione in corso nel Bel Paese. Infatti, reverse flow diventa anche la metafora di un’evoluzione delle reti produttive e dei servizi che, dai distretti italiani, puntano ormai direttamente ai mercati più pregiati, americani e asiatici, scavalcando, in molti settori, i principali comparti manifatturieri tedeschi e nordeuropei.
I dati di questi giorni, che parlano di un Pil che a fine anno (e che anno! con pandemia e guerra) potrebbe segnare un incremento fra i tre e i quattro punti, a fronte di una frenata sia della locomotiva tedesca sia delle stesse Francia e Spagna, fanno intendere come sia mutato sia in quantità, ma soprattutto in qualità, il sistema industriale nazionale. In pochi mesi, si sono concentrati fenomeni come la rilocalizzazione, che ha riportato a casa qualcosa come sessantamila aziende, completamente trasformate sotto il profilo tecnologico rispetto alle stesse unità produttive che erano state decentrate nei decenni scorsi; almeno seicentomila persone hanno abbandonato lavori subordinati per dedicarsi ad attività professionali e artigianali di maggiore soddisfazione; circa cinquantamila giovani sono rientrati dai soggiorni all’estero, delusi dalle prospettive che si chiudevano in altri Paesi. Il tutto nel pieno del gorgo del Pnrr, che vede da due anni, direttamente o indirettamente, il governo pompare nei circuiti d’impresa decine di miliardi di euro.
Diventa così indispensabile ridisegnare le mappe geoeconomiche dei distretti e delle aree tipiche per comprendere quali siano oggi gli interessi dominanti che guidano lo scacchiere imprenditoriale. Non è un caso che, dinanzi alla campagna elettorale, la Confindustria si sia divisa, e mostri grande imbarazzo dopo la caduta di Draghi. Gli equilibri fra il padronato si stanno riformulando: le vecchie famiglie ormai sono in ritirata. La stessa scomparsa di Del Vecchio, il patron di Luxottica, segna l’esaurirsi di un ciclo degli outsider. Per contro, stanno crescendo le cosiddette multinazionali tascabili, startup diventate centri di esclusiva competenza in settori portanti come l’aereospazio, la meccatronica, la robotizzazione.
In queste realtà il lavoro è ormai sempre meno distinguibile da quelle figure neomanageriali di cui parlava, ai suoi tempi, pionieristicamente Adriano Olivetti, e che Bruno Trentin analizzava nella sua relazione al convegno sul neocapitalismo dell’Istituto Gramsci nel lontanissimo 1962. Oggi il quadro è mutato radicalmente: il sapere, o meglio la capacità di innovare l’innovazione – come spiega nel suo saggio L’arco dell’impero, il geopolitico cinese Quiao Liang –, è il vero driver dell’automatizzazione produttiva. Affiorano, infatti, forme di autorappresentazione di queste figure, sotto forma di “gilde artigianali”, dove le vecchie associazioni corporative di origine medievale diventano centri di tutela di saperi e abilità esclusive.
In questo scenario, interrogarsi su come vota questo mondo diventa essenziale. Anche perché questo pulviscolo di piccole e medie imprese tende a non avere niente da chiedere alla politica, e come tale si ritrae dal partecipare alle contese elettorali. In quel 50% di astensionisti possiamo ritrovare gran parte di queste figure neoartigianali. Ma lo scontro aperto sul governo Draghi – e sul ruolo dell’Italia come locomotiva di una strategia di reverse flow, che dall’energia si estende ai principali settori industriali – potrebbe rimetterli in campo. Ma chi parla con loro? Quale cultura politica è oggi in grado di interloquire con queste figure che competono internazionalmente sulla base del valore aggiunto della produzione più che sui costi di produzione?
Il sindacato non sembra ancora avere registrato queste trasformazioni. Il silenzio della Cgil sui temi delle infrastrutture digitali, come cloud e banda larga, lo dimostra. Cosi la stessa sinistra, perfino quella più disponibile a ragionare in termini meno conflittuali, confonde la modernità con la subalternità a questi processi. Del tutto avulsi da questi ragionamenti anche i segmenti tecnocratici di Calenda e Renzi, che chiacchierano sulla modernizzazione del Paese, ma poi non afferrano i processi concreti e reali che richiedono radicalità di proposte e non moderatismo di metodo.
Il reverse flow industriale è una tendenza che va irrobustita con strategie di autonomia e sovranità tecnologica sui gangli vitali dei processi intelligenti, come le memorie e gli algoritmi. Se non si sperimentano forme di attivizzazione sociale nella negoziazione di queste strumentazioni, che non possono essere delegate ai fornitori, peraltro concentrati dai gruppi monopolisti della Silicon Valley, non riusciremo a trovare un linguaggio che declina democrazia e sviluppo, senza dover regalare alla destra le categorie di impresa e competizione.









