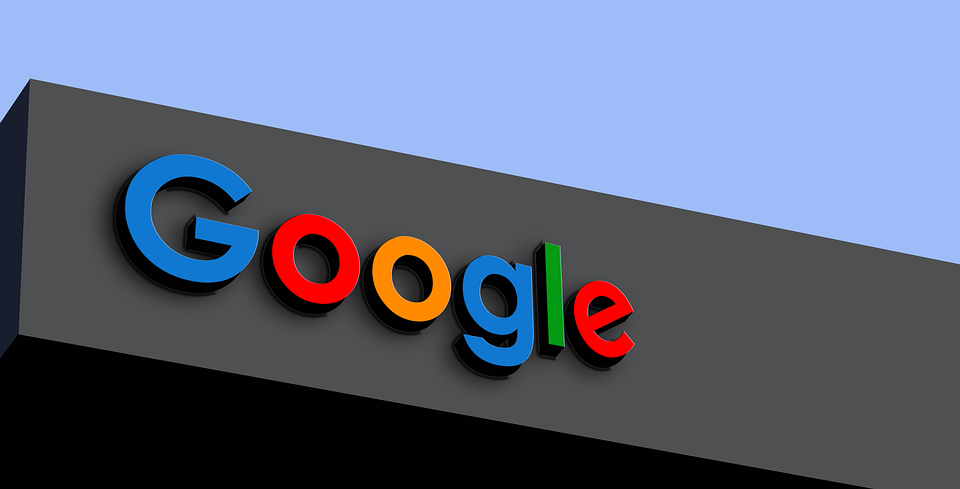
“Sebbene la legge nella maggior parte dei Paesi non definisca l’ambito dei contenuti protetti, abbiamo avviato trattative con centinaia di editori in diversi Paesi, tra cui Germania, Ungheria, Francia, Danimarca e Paesi Bassi in cui la norma è ora in vigore. Oggetto di queste trattative sono le anteprime estese delle notizie, che vanno oltre i semplici collegamenti e gli snippet. Ove possibile, queste offerte tengono conto dei lettori delle testate, della ‘natura giornalistica’ delle pubblicazioni di stampa e dell’investimento editoriale”. Non si specifica quanto saranno pagati gli editori. Con questo tono sprezzante, da concessione privata a poveri questuanti, Sulina Connal di Google ha annunciato la decisione del motore di ricerca più potente del mondo di gratificare circa trecento editori in tutta Europa per quell’azione di estrazione – se non vogliamo usare il termine più tecnicamente pertinente di saccheggio – dei contenuti editoriali in tutto il mondo, che si attua da poco meno di un ventennio.
La direttiva europea – approvata tre anni fa, dopo un lungo braccio di ferro con le lobby della Silicon Valley che fino all’ultimo avevano puntato a impedirne l’approvazione – prevede in termini molto generici, e largamente affidati alla discrezionalità dell’estrattore (leggi saccheggiatore) dei contenuti, le forme di retribuzione a editori e autori dei testi che vengono linkati. La formula della norma prevede una graduazione del livello di citazione, per arrivare al riconoscimento del diritto d’autore. Google, il gruppo che monopolizza circa il 90 % delle attività di ricerca in tutto il pianeta, interpreta questa legge in maniera assolutamente disinvolta, esercitando un potere assoluto sia sulle procedure di remunerazione sia, soprattutto, sulla scelta dei beneficiati.
Infatti, il vero buco nero della legislazione europea, frutto di una mediazione al ribasso con la potente armata di corruttori legali che operano a Bruxelles alle dipendenze della società americana, è proprio il criterio di scelta dei gruppi a cui riconoscere una minima remunerazione per quanto ricavato dai contenuti linkati. Google si trova così a esercitare un diritto di scelta, che sempre più coincide con la prospettiva di vita degli stessi editori, i quali si vedono schiacciati nel progressivo processo di digitalizzazione fra la pressione dei gruppi monopolistici della rete e le modalità di consultazione degli utenti. In questa morsa, Google si permette di discriminare i buoni dai cattivi, decidendo chi ha diritto alla remunerazione dei contenuti, del tutto inadeguata e sottostimata, e chi invece viene abbandonato alla deriva.
Un obbrobrio, frutto di una colossale mancanza di visione e di maturazione culturale dell’intero sistema editoriale europeo. Sono stati, infatti, proprio gli editori – e con loro, dobbiamo riconoscere, anche i giornalisti rappresentati da sindacati e associazioni sempre più miopi – a sollecitare queste forme di beneficienza legale che assegnano a Google il potere di “pesare” i contenuti che selezionano per rispondere alle domande dei miliardi di utenti tutti i giorni. Si tratta di un abbaglio che stravolge le gerarchie e le prospettive di un settore sensibile per la democrazia. Il punto riguarda il concetto di valore in rete. Esattamente come se discutessimo di politica economica: chi deve battere moneta? Il copyright, in una società della comunicazione quale la nostra, è esattamente l’equivalente del conio in un’economia convenzionale.
L’errore, che soprattutto la sinistra esibisce quasi con orgoglio, è proprio quello di adattare alla nuova dimensione virtuale le regole della cultura analogica, basata sulla retribuzione diretta. Nella rete il valore è dato dalla potenza di organizzazione automatica della distribuzione, non dalla capacità di produzione. Dunque non è il copyright tradizionale che deve essere protetto, ossia la rendita della retribuzione di un contenuto, quanto il controllo del sistema di profilazione e abbinamento di ogni singolo testo o video con ogni singolo utente. Questa funzione è la matrice del potere monopolistico di Google, che va contestato e smantellato.
Da questo punto di vista, appare del tutto velleitaria e impotente l’ambizione di editori e giornalisti di trovare direttamente nelle pieghe della munificenza di Google le risorse che una trasformazione radicale delle ragioni di scambio sul mercato intellettuale hanno sottratto ai vecchi produttori della materia prima, ossia dei contenuti. Piuttosto, questo mondo del lavoro intellettuale dovrebbe chiedersi come riprendere il controllo del sistema, contestando a Google proprio l’esercizio esclusivo della potestà di selezionare ed estrarre i contenuti dalla fornace della produzione digitale. In sostanza, si tratterebbe di negoziare non tanto la misera retribuzione di qualche milione di click a questo o quel testo, peraltro scelto a insindacabile giudizio di Google, quanto la capacità del motore di ricerca di raccogliere, selezionare le richieste degli utenti collegandole al flusso dei contenuti. In questa logica, l’obiettivo sarebbe lo scambio fra la massa delle notizie o delle elaborazioni, da parte degli autori, e la gestione della piattaforma.
Google dovrebbe – come in altre occasioni fu deciso in base a norme antitrust, per gruppi come Ibm o AT&T – smembrare il proprio apparato organizzativo monopolista, permettere l’accesso al cruscotto di comando della piattaforma a ogni singolo titolare di contenuti, che potrebbe riorganizzare quella parte dell’attività di Google diretta al proprio mercato.
I giornalisti e gli editori invece di svendere per un piatto di lenticchie la capacità di parlare ai propri utenti, e di profilarli, dovrebbero riprogrammare quelle componenti del sistema Google che abilitano lo scambio fra domanda e risposta nella rete. In questa logica, si profilerebbe anche una nuova dinamica conflittuale, che potrebbe ridare forma e forza a dinamiche politiche in cui le opinioni non siano figlie di un solo algoritmo.









