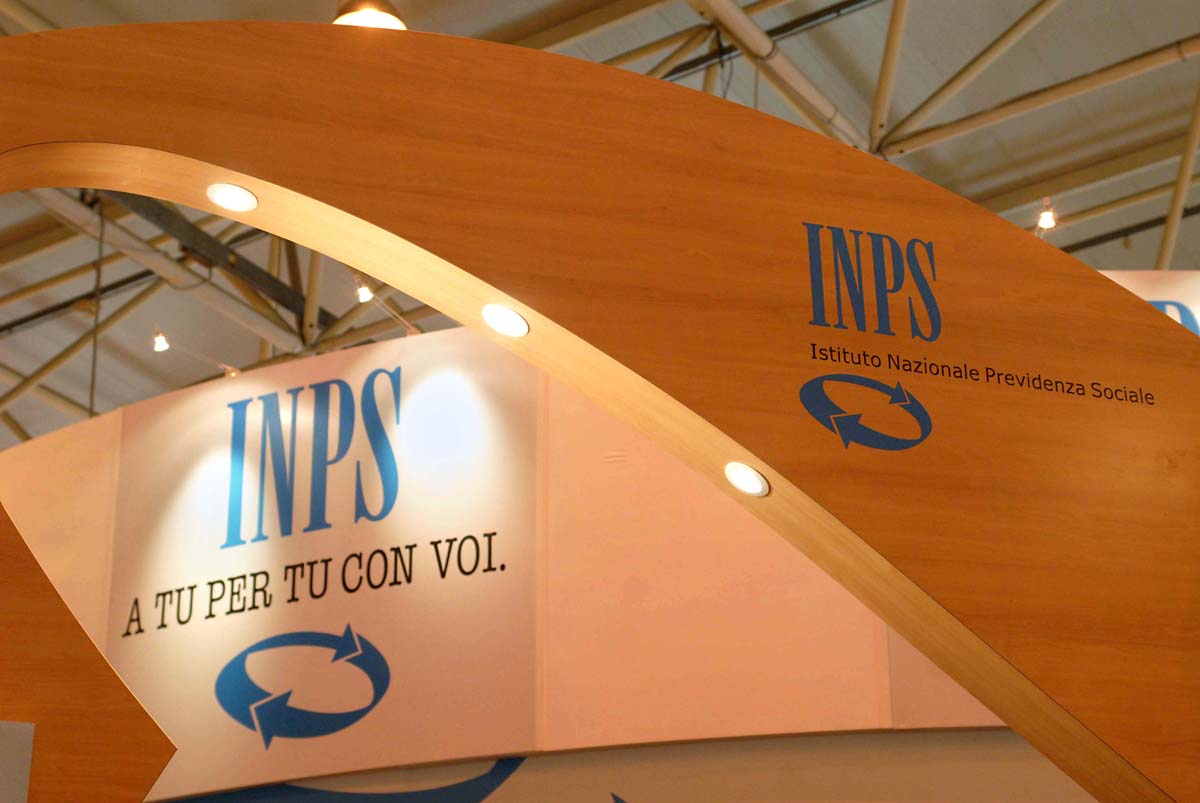
La notizia è arrivata direttamente dal presidente del Consiglio, Mario Draghi: la discussione con i sindacati sulla riforma della previdenza è ufficialmente aperta. Il fatto ha una doppia rilevanza nel merito e nel metodo (perdonate il linguaggio gergale). Ma sia nel merito sia nel metodo le buone intenzioni della politica dovranno essere messe alla prova dei risultati concreti, che si raggiungeranno nei prossimi mesi, anche se – come ha fatto notare il leader della Cgil, Maurizio Landini – è la prima volta che un governo sceglie il confronto per ripensare il sistema previdenziale. Nelle tante riforme degli anni Novanta del secolo scorso non era mai successo.
Ma le buone notizie – almeno per ora – finiscono qui. Il nuovo assetto del sistema previdenziale pubblico italiano è infatti tutto da costruire. Il 2022 sarà l’anno ponte che si baserà ancora sul sistema delle quote: molto probabilmente dopo “quota 100” sarà la volta di “quota 102” (la somma degli anni anagrafici e di quelli contributivi). Dal gennaio 2023, per non tornare in pieno regime di riforma Fornero (riduzione delle prestazioni e allungamento dei tempi di uscita dal mercato del lavoro), si dovranno però introdurre nuove regole per dare più potere di scelta, più flessibilità, ai lavoratori nella decisione di lasciare il lavoro.
Attualmente noi italiani abbiamo il record in Europa dell’età più alta – 67 anni – per avere diritto alla pensione di vecchiaia. Un record frutto della logica che è stata il pensiero previdenziale dominante degli ultimi trent’anni: allungare l’età pensionabile per ridurre il carico di spesa pubblica.
Il corollario della scelta del metodo “concertativo” riguarda quindi un ripensamento delle fondamenta stesse del diritto alla pensione. Sappiamo che per il pensiero neoliberista le pensioni sono una delle voci più pesanti e meno legittime nelle scelte di politica pubblica, un orpello, un macigno che pesa sul libero dispiegarsi dello sviluppo del mercato. Per una parte del pensiero economico si dovrebbe passare, quindi, da un sistema di welfare garantista (troppo sbilanciato sulla spesa per pensioni) a un sistema privatizzato basato su rendite previdenziali costruite a “capitalizzazione” dagli individui singoli nel corso della loro storia lavorativa. Parlando di riforme, si rimettono in gioco i principi basilari della moderna convivenza. Vediamo la questione un po’ più da vicino, cercando di rispondere prima di tutto alla domanda delle domande: ma la pensione è un diritto? Quali sono le sue fonti giuridiche?
La fonte primaria è ovviamente la Costituzione del 1947, che all’articolo 38 parla di invalidità, vecchiaia, assistenza e previdenza. Sostanzialmente, per semplificare, l’articolo si divide in due parti: la prima dedicata alle persone che per ragioni fisiche o psichiche non possono lavorare: “Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all’assistenza sociale”. Il secondo aspetto dell’articolo 38 è quello che ci interessa direttamente a proposito del discorso sulle pensioni. “I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria”. I costituenti non hanno usato la parola “pensione”, ma il concetto di diritto alla previdenza è insisto nel concetto di “mezzi adeguati” alle esigenze di vita dei lavoratori in caso di infortunio, malattia, invalidità, disoccupazione involontaria, nonché appunto “vecchiaia”. Finita la stagione del lavoro attivo, secondo il legislatore, deve essere garantito al lavoratore (che ha contribuito alla società con il suo lavoro vivo e con il versamento dei contribuiti) un tenore di vita dignitoso.
Nella Carta costituzionale troviamo quindi le fondamenta, ma non l’edificio completo. Si stabilisce però il principio che il diritto alla pensione è un diritto soggettivo pubblico, in virtù del quale a tutti i lavoratori e parimenti a tutte le lavoratrici esso è riconosciuto e garantito dalla Costituzione. Se queste sono le fondamenta, l’edificio (ovvero come devono essere calcolate le pensioni, come si erogano, quando si può andare in pensione, chi le eroga, ecc.) è stato costruito con le miriadi di interventi legislativi della storia repubblicana. Negli anni Novanta (dal 1990) si sono concentrare le riforme più importanti: Amato, Dini, Berlusconi, Prodi, Maroni, Monti-Fornero, Damiano, Padoa Schioppa, solo per ricordare qualche nome.
Nel momento in cui si dovrà mettere mano alla legislazione vigente (la riforma Fornero), si dovranno ripensare i sistemi di calcolo della rendita previdenziale, il rapporto tra pensione e aspettativa di vita, il problema dell’equità interna al sistema (donne e giovani sono oggi le categorie penalizzate); e si dovranno individuare i nuovi criteri per permettere ad alcune categorie di lavoratori di poter andare in pensione prima della data fissata come limite della vecchiaia. In questo senso è già iniziato un lavoro di studio e di confronto sui lavori cosiddetti “gravosi” o “usuranti”. Si dovrà quindi ripensare il concetto di eguaglianza.
Dire che tutte le persone sono uguali, in tema di previdenza, significa introdurre, da subito, un principio di ingiustizia e ineguaglianza. Perché è vero che il diritto è tale solo quando è uguale per tutti, ma è anche vero che un conto è aver lavorato per tutta una vita su una impalcatura edile, altra cosa averlo fatto in ufficio svolgendo lavori meno “usuranti” e a rischio. Anche l’entità dell’assegno dovrà essere rivista alla luce dei nuovi criteri. Si dovrà, cioè, ripensare a quella definizione dell’articolo 38 “mezzi adeguati”.
Oggi la stragrande maggioranza delle pensioni erogate è sul limite della sussistenza, mentre è palese – e riconosciuta anche a livello istituzionale – una ingiustizia “interna” al sistema. Lo ha confermato di recente anche il presidente dell’Inps, Pasquale Tridico, secondo il quale i poveri pagano le pensioni dei ricchi, perché hanno un’aspettativa di vita minore e, una volta lasciato il lavoro, muoiono prima. “I cittadini con le pensioni più basse e che vivono meno a lungo finanziano i cittadini con le pensioni più alte che vivono più a lungo, e questo per l’Inps deve cambiare”, ha spiegato il presidente presentando il ventesimo rapporto Inps alla Camera dei deputati.
Per rendere dunque il diritto alla previdenza davvero uguale per tutti, sarà necessario – paradossalmente – introdurre elementi di diseguaglianza nelle norme. Un’altra ingiustizia, o stortura, da correggere riguarda, per esempio, l’annosa questione del gender gap e delle pensioni dei giovani. Nella discussione sulla riforma si dovrà tenere conto delle grandi diseguaglianze tra la pensione delle donne e quella degli uomini. Le donne hanno infatti pensioni mediamente più basse, perché hanno lavori meno pagati e devono fare i conti spesso con interruzioni delle carriere professionali, a causa di scelte famigliari e assistenza dei congiunti malati.
Accanto a questa, c’è la grande questione giovani. Con i lavori precari e discontinui, che oggi sono la consuetudine del mercato del lavoro, è quasi impossibile costruire una pensione contributiva in grado di assicurare un livello di vita dignitoso una volta andati in pensione. Si propone, dunque, l’introduzione di una pensione di garanzia contributiva basata su un concetto di solidarietà generale. Se il lavoratore ha svolto lavori precari, o si trascina troppi “buchi contributivi” e non matura una pensione sufficiente, dovrà essere lo Stato a intervenire con una integrazione. Una garanzia appunto.
Si apre qui un altro problema. Chi deve pagare le pensioni? Lo Stato attraverso i contributi dei lavoratori e delle aziende, o lo Stato attraverso la fiscalità generale? E come si fa a garantire a giovani che hanno lavori mal retribuiti un risparmio previdenziale integrativo con i fondi pensione, quando i loro redditi non permettono attualmente alcun accantonamento per il futuro? Sono questi alcuni dei temi dell’agenda dei prossimi mesi. Oggi è impossibile anticipare ilfinale.













