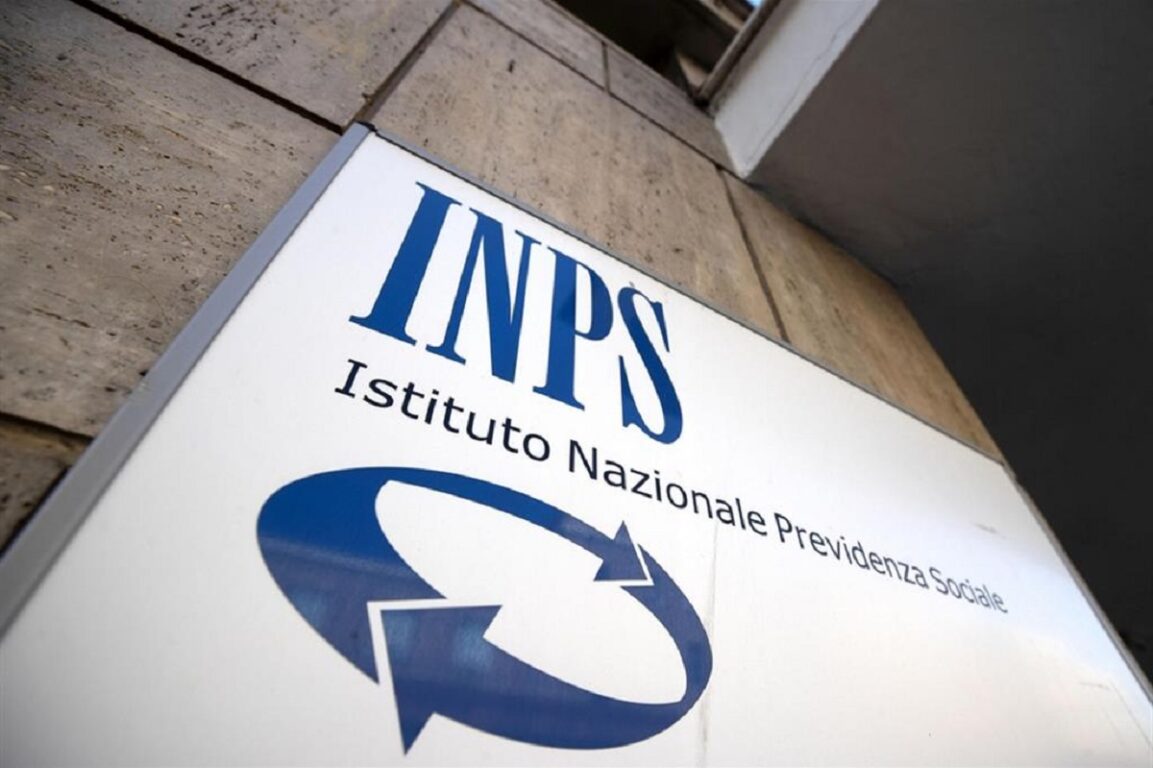
Aveva settant’anni Romano Bonfatti, e secondo il “Corriere della sera” (per citarne uno) “era regolarmente assunto” presso la ditta esterna incaricata di ispezionare il tetto del capannone di una officina. È morto dopo essere caduto da un’altezza di otto metri. Saranno le autorità competenti a individuare cause e responsabilità; ma è interessante notare come la dicitura “operaio di settant’anni” venga usata senza particolari note a margine su molte testate locali e nazionali. Non è il primo caso e non sarà l’ultimo: solo una coincidenza che colpisce nei giorni in cui si torna a discutere di “sostenibilità” del sistema previdenziale in coincidenza con la scadenza temporale di “quota 100”, provvedimento transitorio adottato tre anni fa, con l’obiettivo di favorire una corposa sostituzione di anziani con giovani lavoratori, ma che – com’è noto – non ha raggiunto appieno i suoi obiettivi (hanno aderito in 341mila, soprattutto uomini con una forte continuità lavorativa, rispetto al milione atteso dai promotori; mentre il tasso di sostituzione con nuovi lavoratori secondo Confindustria è di 0,4 assunti per ogni pensionato anticipato, anche se va considerata la drammatica frenata dovuta alla pandemia).
Mesi fa Mario Draghi aveva dichiarato, per rispondere a chi parlava di tassa di successione o di patrimoniale, che il 2021 “è un anno in cui non si chiedono soldi, ma si danno soldi”; oggi si prepara, secondo quanto ha spiegato lui stesso, a superare “quota 100” con la legge di bilancio che dovrebbe essere licenziata in questi giorni dal Consiglio dei ministri. La proposta elaborata dal ministero dell’Economia indica “quota 102” nel 2022 e “quota 104” nel 2023 come passaggi transitori.
Sui giornali di fiducia già circolano veline governative che indicano come ridottissimi i margini di negoziabilità di questo ritorno alla “normalità” (ovvero la legge Fornero: sempre parole di Draghi). I sindacati confederali, pur a suo tempo scettici sul provvedimento del governo Conte 1, fanno sapere che la “gradualità”, così calcolata, limiterebbe la finestra di uscita a poche migliaia di persone. E perfino un pensatore non particolarmente sbilanciato a sinistra, come l’ex parlamentare berlusconiano Giuliano Cazzola, liquida così la proposta del ministro Franco: “Questo vuol dire che lo scalone si trasforma in un tunnel da cui non si esce”.
Come accade da almeno trent’anni a questa parte, tuttavia, il confronto sullo specifico punto tecnico – la scadenza di “quota 100” – è l’occasione per riaprire lo scontro costante sulla “sostenibilità” del sistema previdenziale italiano, pur convertito da decenni al metodo di calcolo contributivo, a partire dalla riforma Dini che risale al 1995, sia pure attraverso un sistema graduale, peraltro appesantito nei suoi risvolti sociali dalla riforma Fornero del 2012. Sostenibilità messa in discussione dal lungo declino economico del Paese, dall’introduzione dei mille strumenti della cosiddetta flessibilità contrattuale che ha reso il lavoro dipendente stabile solo una delle forme del rapporto di lavoro e dal clamoroso – e non casuale – corrispondente arretramento dei salari (i dati Ocse dimostrano che le retribuzioni italiane in trent’anni sono calate del 2,9%, mentre in Francia e in Germania sono salite più del 30%).
L’Italia spende più di altri Paesi in materia di previdenza pubblica, e per questo è costantemente sotto tiro da parte di studiosi non sempre disinteressati (l’ultimo rapporto pubblicato dal “Sole 24 Ore” è promosso da Mercer, una grossa società di consulenza in materia di risorse umane, sistemi previdenziali e investitori istituzionali). Ma, com’è ampiamente noto, su altri versanti della spesa pubblica per il welfare, l’Italia è costantemente in ritardo (istruzione, università, ricerca) o da anni subisce una dura contrazione dei fondi dedicati (sanità) accompagnata da una distribuzione diseguale sul territorio e spesso sbilanciata a favore del privato, che ha obiettivi a volte differenti da quelli del soggetto pubblico.
Tuttavia, anche limitandosi a considerare la materia pensionistica, sarebbe un grave errore trascurare i segnali d’allarme sulle crescenti diseguaglianze sociali all’interno del sistema previdenziale lanciati dall’Inps nel suo ultimo rapporto. Secondo l’Istituto tra “il 2012 e il 2020”, la “diseguaglianza di genere tra i pensionati” si è accresciuta. Inoltre si segnala una “differenza nella aspettativa di vita legata alla condizione socio-economica. Dall’analisi emerge come questo sia un problema significativo principalmente per la popolazione maschile, per cui il passaggio dal primo al quinto quintile della distribuzione dei redditi pensionistici si associa a un guadagno in termini di speranza di vita a 65 anni superiore ai due anni”. Temi drammaticamente attuali, che non dovrebbero sparire dal terreno di confronto fra il governo, i partiti di maggioranza e le parti sociali, se non si vuole rischiare di perdere l’ennesima occasione per mettere mano agli squilibri sociali del “sistema Italia”. E per non rischiare di guardare a un futuro in cui i casi come quello dell’operaio settantenne morto sul lavoro diventino (o rimangano) la normalità.









